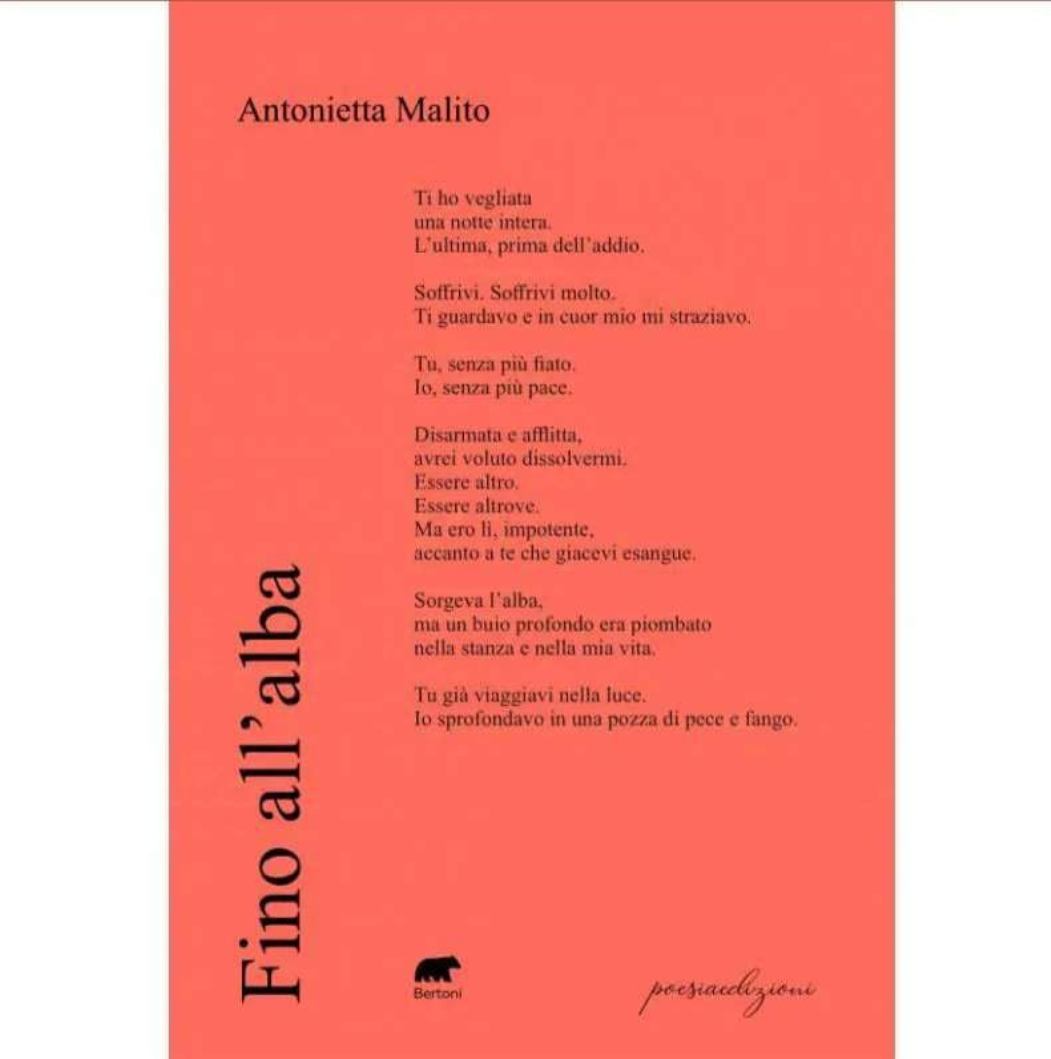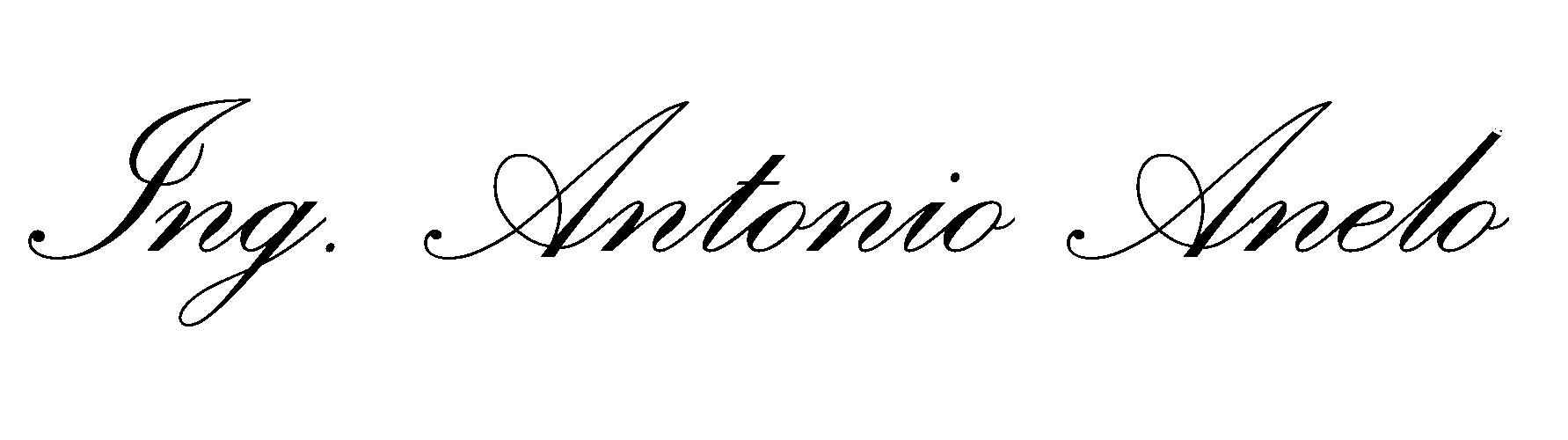Letteratura: il 2 Aprile pv alle ore 21, Libreriamo intervista Alberto Micelotta per il suo Pietre di Suono, la Poesia Uccide.
Poesia e Psicologia
di Paolo Russo
Molto spesso si sente parlare della psicologia come di una disciplina scientifica oppure come di un genere letterario che di scientifico non ha proprio nulla.
La poetessa Ana Di Risio si racconta
Gentilissima Ana Di Risio benvenuta, sono lieta che tu abbia accettato di essere intervistata sul giornale “LA VOCE agli italiani”. Sei una poetessa, una speaker radiofonica e un'insegnante argentina di origini italiane. Parlaci di te.
Varese / Intervista a Ciro De Angelis, docente e scrittore, che presenta il suo ultimo libro
Per il giornale “La Voce agli italiani”, l’intervista allo scrittore Ciro De Angelis. Nato a Taranto nel 1963, Ciro ha conseguito due lauree, in Filosofia e in Scienze della Formazione Primaria.
Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, esprime la sua solidarietà a Nicola Gratteri
Lecce / Il nuovo libro della scrittrice e poetessa Lucia Babbo. Particolari su “La VOCE agli italiani”
Lucia Babbo è una scrittrice e poetessa salentina di origini abruzzesi, da poco ha pubblicato un nuovo e bellissimo romanzo intitolato “olfatto”: a lei la parola. Benvenuta Lucia parlaci di te. Com’è nato il titolo così particolare e d’impatto? Cosa rappresenta per te l’olfatto?
Potenza / Il docente Francesco Calabrese si racconta al giornale “La VOCE agli italiani”
Benvenuto Francesco, Grazie per questa intervista. Sei un docente di lettere classiche, io ti definisco anche “artista poliedrico”, con interessi che si allargano a ventaglio in diversi settori. Ce ne parli?