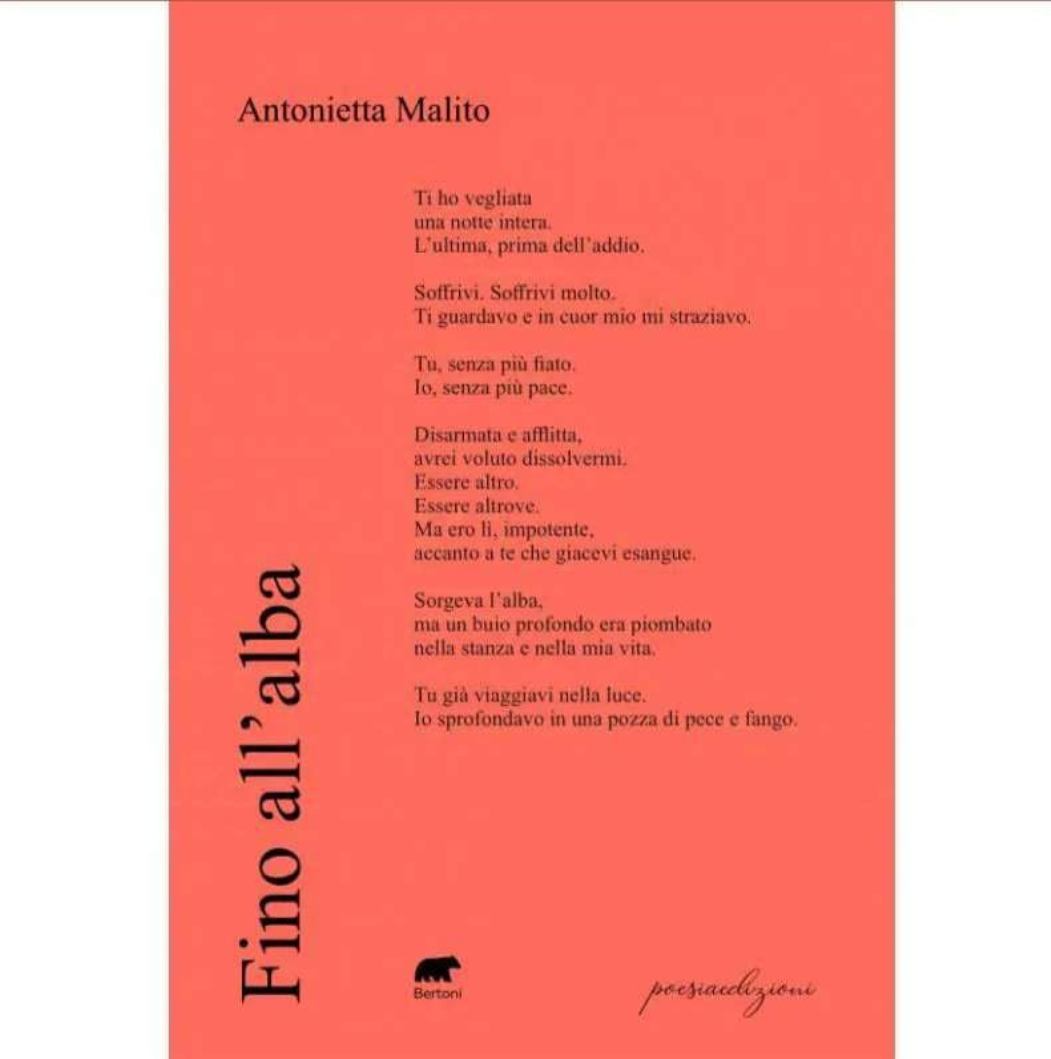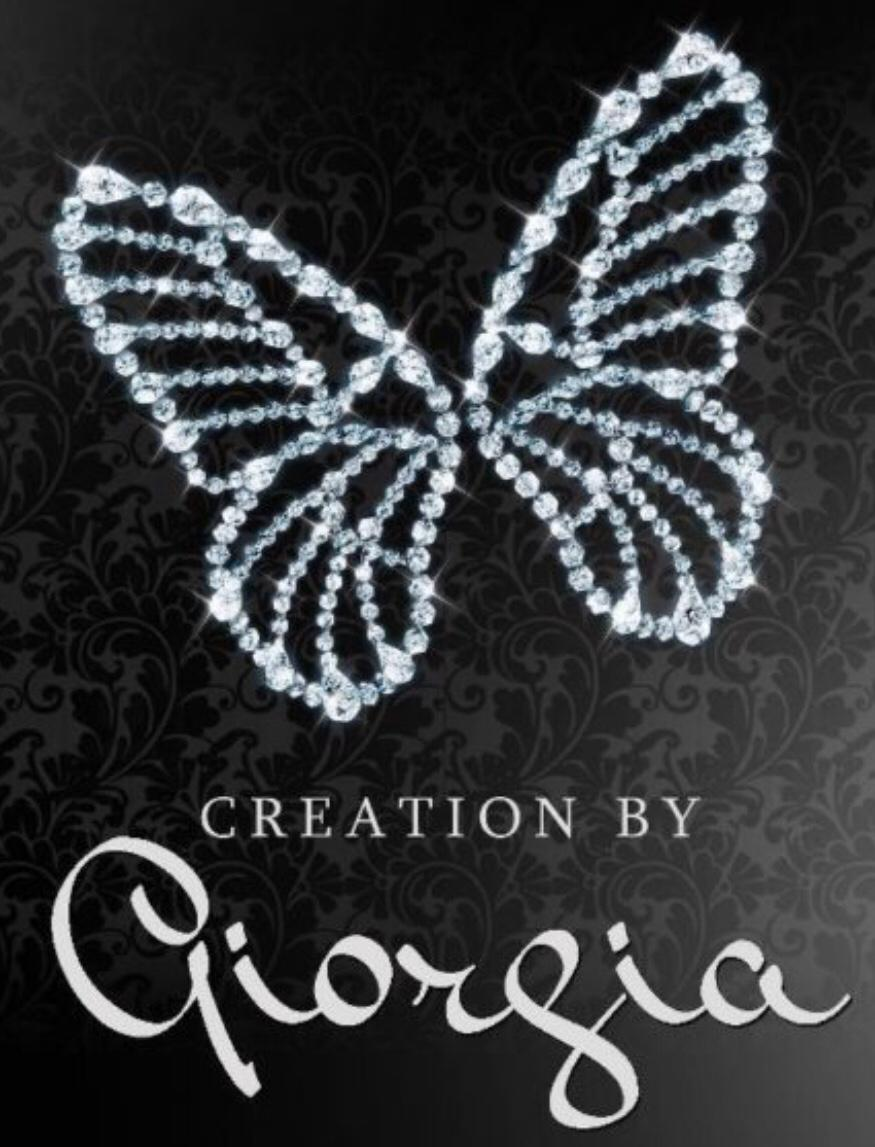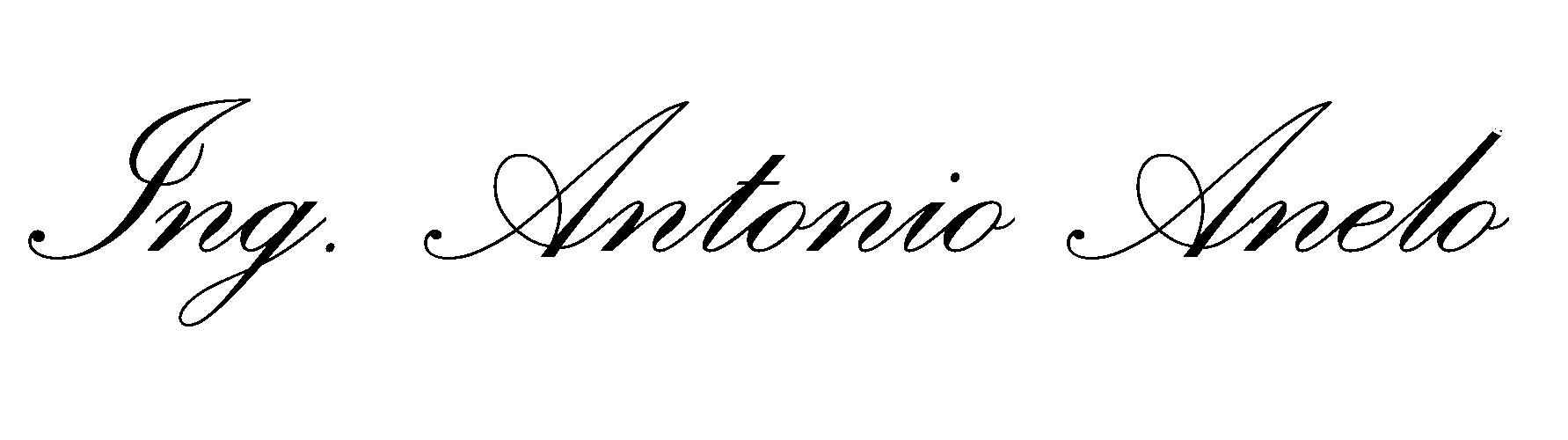di Michele Petullà
Si celebra oggi, come ogni anno, la giornata della memoria: la ricorrenza dell’apertura dei cancelli di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945.
Riflettere sull’Olocausto significa fare i conti con la sua tragicità, ma anche porsi degli interrogativi la cui risposta implica uno sconvolgimento dei valori tradizionali. Sono molti e diversi, infatti, i problemi che gli intellettuali si sono trovati a dover affrontare, di carattere politico o religioso, come la nota questione posta dal filosofo tedesco Hans Jonas (1903 - 1993), all’interno del suo scritto Il concetto di Dio dopo Auschwitz: una voce ebraica (1987), sulla reale onnipotenza di Dio. In esso il filosofo sostiene, appunto, che Auschwitz rappresenta per l’esperienza ebraica della storia una realtà assolutamente nuova e inedita, che non può essere pensata e compresa con le categorie concettuali tradizionali. L’Olocausto ha spezzato la continuità delle categorie per pensare Dio, la storia e il male, ma anche il linguaggio per cantare o piangere il mondo.
Uno degli interrogativi più spinosi riguarda l’ambito estetico e letterario, e quello poetico in particolare. Come deve rapportarsi la poesia a quell’esperienza storica, a un evento tragico come l’Olocausto, in grado di scuotere e inorridire tutto il continente europeo, e non solo? Rispondere a questo interrogativo implica, in parte, negare una tradizione ancorata nei secoli, svalutare artificiosamente tutti quei principi da sempre associati al fare poetico. Il verso, all’indomani del primo conflitto mondiale si è indubbiamente dimostrato il luogo ideale in cui raccontare l’orrore delle carneficine e delle trincee, basti pensare a Grodek (1914), la toccante poesia sugli orrori della guerra del poeta austriaco Georg Trakl (1887 - 1914), o ai versi ungarettiani nel contesto italiano. Di fronte, invece, alle incalcolabili morti causate dall’ideologia antisemita nei confronti dei “Figli di Israele”, di cui non rimane altro che cenere, il poeta sembra ammutolire.
Una delle risposte più famose a questa questione è quella data nel 1949 da Theodor Adorno – filosofo, sociologo, musicologo e accademico tedesco, tra i principali fondatori ed esponenti della Scuola di Francoforte, che si distinse per una critica radicale alla società ed al capitalismo avanzato – all’interno del saggio Critica della cultura e della società: “La critica della cultura si trova dinnanzi all’ultimo stadio della dialettica di culture e barbarie. Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie, e ciò avvelena la stessa consapevolezza perché è divenuto impossibile scrivere oggi poesie.” Un’affermazione particolarmente forte e pesante, radicale, che ha fatto discutere molto e acceso un intenso dibattito sul rapporto fra intellettuali e società, che evoca il senso di una sconfitta epocale difronte al nazismo e all’Olocausto. Nel corso degli anni successivi, Adorno avrebbe chiarito meglio il suo pensiero e i fraintendimenti a cui, secondo lui, era stato sottoposto. Nel saggio Note per la Letteratura (1958), infatti, il filosofo scriveva: “Il dire che dopo Auschwitz non si possono più scrivere poesie non ha validità assoluta, è però certo che dopo Auschwitz, poiché esso è stato possibile e resta possibile per un tempo imprevedibile, non ci si può più immaginare un’arte serena”. Ancora più chiaramente Adorno si esprimeva nel saggio Dialettica negativa (1966): “Il dolore incessante ha altrettanto diritto di esprimersi quanto il torturato di urlare; perciò forse è sbagliato aver detto che dopo Auschwitz non si può più scrivere poesie.”
Al di là delle reazioni suscitate all’epoca dalla originaria affermazione di Adorno, sembra oggi piuttosto consolidata l’interpretazione secondo cui il filoso tedesco volesse sottolineare il significato di cesura che l’aberrazione morale della Shoah rappresenta per la storia dell’umanità a tutti i livelli: etico, sociale, politico, ma anche filosofico e letterario. La ferocia nazista sembrava aver spazzato via ogni fede nell’umanità ed Auschwitz rappresentava la prova del fallimento della cultura. Con il suo famoso aforisma, Adorno non intendeva certo enunciare un giudizio sul futuro della poesia come genere letterario, ma esprimeva piuttosto un dubbio rispetto alla capacità dello stesso pensiero critico di misurarsi con l’Olocausto: egli intendeva segnalare una cesura epocale, non sul piano storico o diacronico, ma sul piano della soggettività. Le parole di Adorno, inoltre, contengono una contro-verità: la verità del “non tutto è dicibile”; la verità del silenzio come condizione perché la parola non divenga mera chiacchiera o semplice riempitivo di un vuoto; la verità del divieto di trasformare la poesia su Auschwitz in occasione di ideologia o di catarsi per ciò che non può essere espiato. Secondo Irving Howe (1920 - 1993) – critico letterario statunitense – nelle parole di Adorno c’è come un ritorno a un “sentimento religioso primitivo”: il sentimento che esistono, nella nostra esperienza, cose che sono troppo terribili per essere guardate in faccia e per poterle raccontare, come nelle religioni e nelle mitologie antiche, dove vi sono cose che non possono essere nominate. In sostanza, dunque, Adorno intendeva risvegliare le coscienze assopite e invitarle a rielaborare il dramma della Shoah attraverso anche la scrittura, creando nuove e più convincenti forme estetiche. Perché la parola è uno strumento di testimonianza fondamentale, in quanto permette alla memoria di essere tramandata alle nuove generazioni.

Riprendendo l’originaria affermazione di Adorno, d’altra parte, Primo Levi (1919 - 1987) – superstite di Auschwitz e scrittore – sostenne proprio la necessità della parola, di parlare, di raccontare, continuamente, l’Olocausto: “la mia esperienza è stata opposta, in quegli anni avrei riformulato le parole di Adorno: dopo Auschwitz non si può fare poesia se non su Auschwitz.” Quello di Levi è un vero e proprio imperativo categorico e morale, che sancisce il dovere alla testimonianza, a tenere in vita la memoria di quello che è stato: l’esperienza del singolo deve porsi al servizio della memoria collettiva, per fare luce sulla cicatrice più significativa della società contemporanea. Alla descrizione minuta delle vicende del campo di concentramento, nelle sue opere Levi affianca anche descrizioni in tono meditativo, che cercano di trovare un impossibile “perché” a quello che ha vissuto in prima persona, e più in generale all’Olocausto. L’urgenza della rivelazione cede quindi progressivamente il passo a un’esigenza più sottile e nello stesso tempo più difficile da placare: descrivere il lager implica sempre più indagare le radici stesse dell’agire umano, per comprendere come Auschwitz sia stata possibile. “È accaduto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire”: con questa frase cruda e lapidaria – riportata nella sua ultima opera, I sommersi e i salvati (1986), punto di arrivo della sua riflessione sulla Shoah – Levi trasmette tutto il terrore e l’orrore che ha provato nel Lager e lo trasmette ad ogni essere umano che non l’ha vissuto. Quello che è accaduto può succedere di nuovo, bisogna quindi ricordare, non dimenticare, tenere viva la memoria di quello che è stato, e capire il perché tutto ciò può essere accaduto, affinché non accada più: la memoria è l’avvertimento che apre il futuro.
Tra l’iniziale affermazione di Adorno sulla poesia dopo Auschwitz (1949) e i ripensamenti maturati successivamente, fino alla sua posizione finale (1966), si inscrive il rapporto epistolare tra il filosofo tedesco ed il poeta rumeno, di origine ebraica, Paul Celan (1920 - 1970), che seppure non portò ad un vero e proprio incontro tra i due, segnò sicuramente una svolta nel pensiero del filosofo riguardo la concezione della poesia dopo Auschwitz. Celan perse entrambi i genitori nei campi di concentramento; uscito vivo da quella tremenda esperienza, diversi anni dopo si suicidò, quale tarda conseguenza del contesto della Shoah, vittima di quello che Levi definì, in un’intervista del 1985, ”Veleno di Auschwitz”: veleno di cui sarebbe rimasto vittima, nel 1987, anche lo stesso scrittore torinese.
Celan – considerato il più penetrante poeta della Shoah, sopravvissuto e vittima della sua stessa sopravvivenza – fu probabilmente l’intellettuale che visse nel modo più lacerante la sentenza adorniana, lui che del ricordo della Shoah aveva fatto uno dei punti centrali della sua opera poetica, intesa anche come possibilità di salvezza dall’indescrivibile orrore. Scrive, infatti, Celan: “La poesia in virtù della sua essenza, e non della sua tematica, è una scuola di umanità vera: insegna a comprendere l’altro in quanto tale e cioè la sua diversità; invita alla fratellanza e contemporaneamente al profondo rispetto dell’altro”. Celan contestò fortemente l’affermazione di Adorno e rifiutò l’accusa di barbarie per aver parlato, nelle sue poesie, dell’orrore di Auschwitz. Celan conosceva bene il valore del monito: la sua poetica si dipana proprio dal doloroso ricordo dell’esperienza terrificante nei campi di concentramento, dall’esigenza di mantenere vivo lo strappo dai genitori, che solo i versi possono alleviare, mantenendo in vita il respiro con la dignità della memoria dell’orrore. Celan, infatti, concepiva la poesia non solo come raffigurazione esemplare dell’immane tragedia di cui è stato vittima, ma anche come possibilità di riconciliazione con la vita e ancor di più – e forse soprattutto – come doverosa testimonianza per tenere vivo il ricordo, la memoria della Shoah. Come poeta segnato indelebilmente da quell’atroce esperienza, Celan sentiva forte questa responsabilità e lo scrivere poesia comporta il suo centro e la sua profondità, infatti scriveva in una lettera: “Le poesie riflettono con coerenza e rigore la storicità della tragedia per una memoria fedele alla verità.” Lo scenario dello sterminio, il ricordo dei morti, pertanto, chiamano al dovere della testimonianza e della memoria: non possiamo permetterci di rendere “muta” la Shoah, è necessario non dimenticare quel dramma. Pertanto, non solo si può, ma si deve fare poesia, per conservare e far rivivere la memoria dell'Olocausto, la memoria dell’immane tragedia che è stato.
Nella poesia di Celan il monito di Adorno si rovescia, pertanto, in una ricerca estrema: Auschwitz, il male storico, diventa il passaggio per un nuovo percorso della parola. Nella sua poetica l’arte riacquista così un obiettivo preciso: quello della memorabilità – e della responsabilità –, del tenere a mente i fatti, del dare significato al ricordo, alla “memoria”. Attraverso la sua poesia Celan scava la parola fino a trovarne e restituirne il senso universale della sofferenza, scortica nell’intimo e più profondo significato di ogni lemma, affinché sia monito ed immagine fissa agli occhi per le generazioni future, come memoria di “ciò che è stato”: orrore e vergogna. La radice stessa dello sforzo poetico, dunque, deve alimentare e custodire per sempre la memoria dell’offesa, anzi, la stessa memoria offesa, perché è la poesia stessa a salvare quella memoria, a redimere ogni memoria futura.