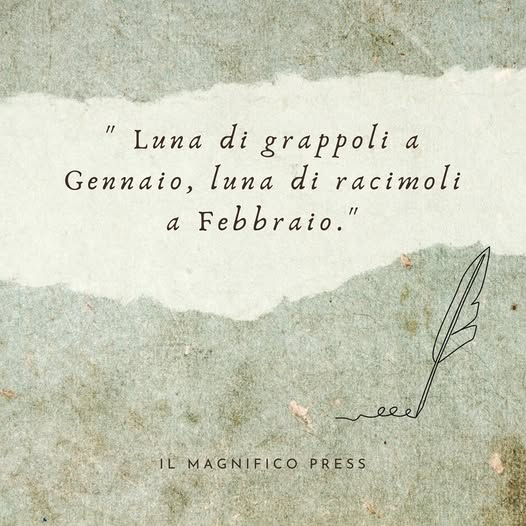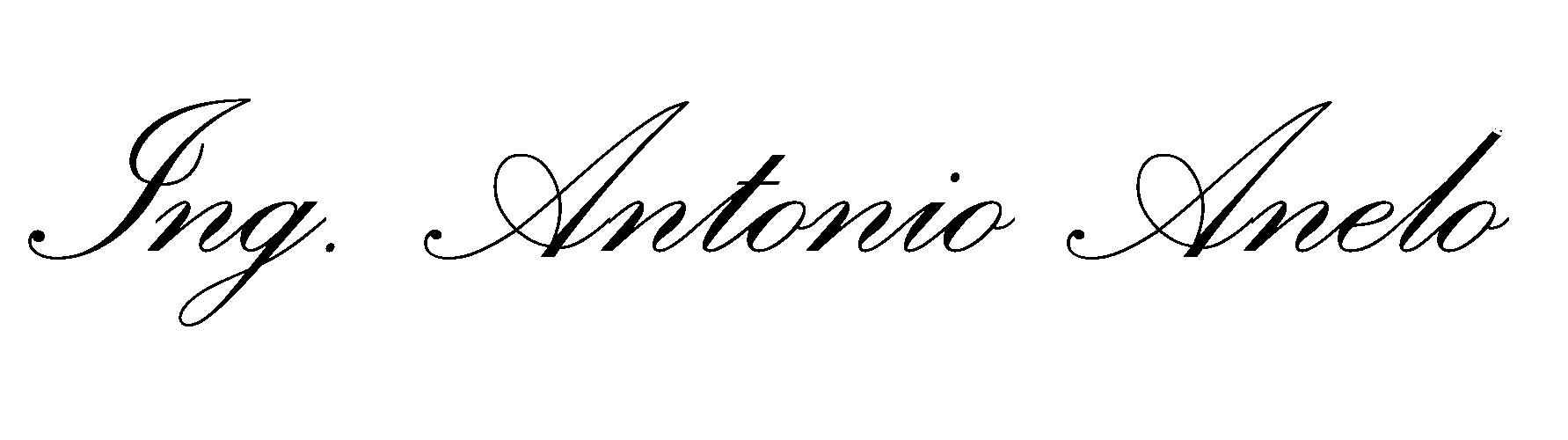di Rita Scelfo
A volte mi piace salire sul treno delle memorie, su “Lu trenu du passatu” che è il titolo di una mia poesia in vernacolo
(…Quantu mi piaci viaggiari ‘nto passatu!
Acchianari nni lu vaguni di la memoria…
Dintra stu trenu sentu ‘na canzuni,
‘na dilusiuni, ‘na cuntintizza,
tutti cosi ca riviu ccu l’ occhi e ccu lu cori.
Eh, sì! Stu viaggiu è propriu emozionanti !...)
e visitare le bellezze della nostra isola: i campi coltivati, i monti dell’entroterra, gli agrumeti, i vigneti e i frutteti i mandorli in fiore della zona di Agrigento che durante la loro fioritura sembra che vogliano raccontare i segreti del loro territorio, le acque ora placide e ora tormentate dei mari che la bagnano e che con i loro vari colori ci regalano gli stati d’animo dei pescatori e della gente del luogo dei quali Verga ha ampiamente descritto. Quanti paesini che, a sera, sembrano dei presepi! E dal finestrino del treno del passato guardo i tanti angoli attraversati e immagino quante emozioni, quanti sentimenti nascondono! Quante vite trascorse, quanti lavori faticosi affrontati senza mai lamentarsi. E vedo i carrettieri che, con enormi sacrifici e sempre ligi al dovere, trasportavano pesanti carichi di merci da un paese all’altro o alle più vicine città. Lungo i loro viaggi, attraversavano paesi nuovi, conoscevano nuova gente e si scambiavano notizie sulle loro merci. I carrettieri erano proprietari del carretto e del cavallo e venivano pagati a seconda del tragitto da compiere e a quello che trasportavano. La vita dei carrettieri si svolgeva lungo le strade (si caminava stratuna stratuna), si fermavano per dar da mangiare e da bere ai cavalli e per rifocillarsi con un piatto di pasta con l’aglio e l’olio (piattu ri pasta cu l’agghiu e l’ogghiu) chiamata ancora oggi “alla carrettiera” e infine riposavano su sacchi pieni di paglia. I carrettieri trasportavano anche ghiaccio tagliato in blocchi, sistemati su della paglia e poi coperti; partivano all’imbrunire per evitare che il ghiaccio si sciogliesse.
Negli anni quaranta e cinquanta nacquero le prime fabbriche di ghiaccio ed alcune ancora esistono come ad esempio quella di S. Flavia, un paesino in provincia di Palermo, e fino a qualche anno fa quella di Palermo presso il Ponte dell’Ammiraglio.
Il pane di Gianni Rodari
S’io facessi il fornaio
vorrei cuocere un pane
così grande da sfamare tutta,
tutta la gente
che non ha da mangiare.
Un pane più grande del sole,
dorato, profumato
come le viole.
Un pane così
verrebbero a mangiarlo
dall’India e dal Chilì
i poveri, i bambini,
i vecchietti e gli uccellini.
Sarà una data da studiare a memoria:
un giorno senza fame!
Il più bel giorno di tutta la storia!
Com’è bella questa poesia di Rodari che con semplici parole ci fa sentire il profumo del pane appena sfornato, il lavoro faticoso dei fornai che si è tramandato nel tempo fino ad oggi.
Se, poi, un piatto o una ciotola si rompeva, interveniva il "conza piatti" che li sistemava con il filo di ferro. Questo è un piatto dei miei nonni; si vedono due buchi in alto e due al di sotto degli stessi attraverso i quali è stato fatto passare il filo di ferro per cucire il piatto.


Conza piatti e lemmi
C’era "U Lattaru" che allevava pecore o capre e portava il latte di casa in casa all’alba; le donne interessate "calavanu u panaru" (dal balcone facevano scendere un pianerino) con una bottiglia o un pentolino dove il lattaru versava il latte richiesto.
Il banditore aveva il compito di girare per le vie del paese, suonando una trombetta per richiamare l’attenzione e comunicare fatti di cronaca, fiere e altri eventi.
Il venditore di cantari vendeva vasi da notte in terracotta; anche ne “Il Gattopardo” si legge di un vano attiguo all’orchestra, con una ventina di vasi, scena ripresa anche nel film di Luchino Visconti.
U Scarparu (calzolaio) era colui che costruiva scarpe cucite a mano su misura alla perfezione e che duravano nel tempo; usava forme in ferro e in legno all’interno delle quali si inserivano le scarpe, il trincetto, gli aghi, la colla, la resina, il vetro per lisciare le suole. A volte, colui che doveva farsi riparare le scarpe, aspettava all’interno della “putìa” ( bottega ) perché non tutti possedevano più paia di scarpe.


IL LAVORO FEMMINILE
Le donne si dedicavano al cucito, al ricamo e ai lavori a maglia fino agli anni 40/50 quando si usavano per il cucito le macchine da cucire. Le sarte insegnavano i loro segreti alle ragazze che dovevano indossare grembiule bianco e lavarsi le mani spesso, quelle mani che realizzavano preziosi ricami.
E c’erano anche le “ lavannere” che andavano a lavare la biancheria presso i lavatoi pubblici.
Alcuni di questi mestieri si svolgevano nelle Putìe (botteghe); la parola “putìa” deriva dalla parola greco-latino apotheka che poi si trasformò in italiano in “bottega”. C’erano le putìe del calzolaio, del falegname, del fabbro, della sarta, del barbiere oppure dove si vendevano diversi alimenti: biscotti, la pasta avvolta nella carta gialla, vino, legumi, farina, formaggi, tutti sistemati in diversi scaffali o in ceste; si pagava e i putiari annotavano il ricavato delle merci vendute su un foglio di carta o mettevano gli incassi in un cassetto. Spesso, nelle “putìe”, ci si riuniva per fare quattro chiacchiere e giocare a carte.
“Fari casa e putia” è il classico proverbio siciliano che si riferisce a chi era riuscito a realizzare la propria putìa accanto all’abitazione.
Alcune putìe furono sostituite dalla nascita dei vari supermercati.

IL MUSEO DEGLI ANTICHI MESTIERI A ZAFFERANA ETNEA
Tutti questi mestieri rappresentano l’anima di un luogo, i suoi sapori, il suo popolo con le varie sensazioni e le emozioni vissute e i tanti sacrifici portati avanti dai lavoratori. Sembra di sentire il suono degli attrezzi da lavoro utilizzati che ci riportano quella nostalgia ricca di “angoli dell’anima e del cuore”; angoli che le nuove generazioni, travolte dal ritmo della civiltà, dovrebbero conoscere perché ricche di umanità e perché illuminano il nostro passato, la nostra storia.