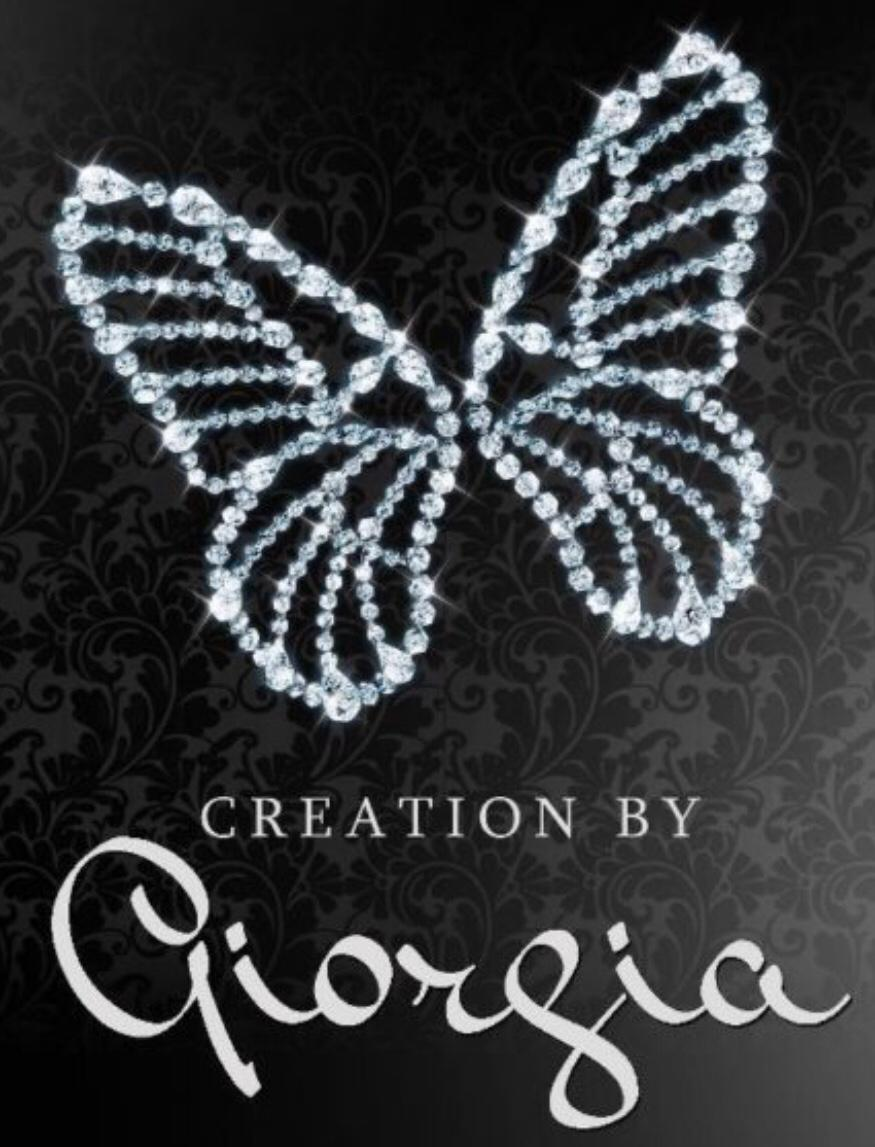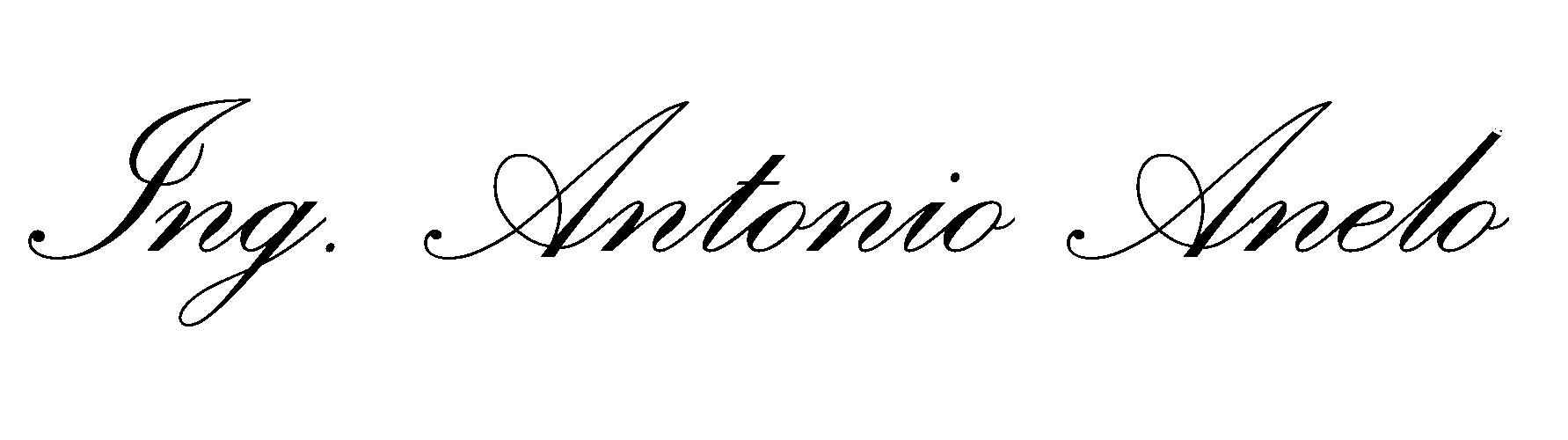di Michele Petullà
Le Torri gemelle di New York che crollano, colpite da due aerei usati come bombe – l’immagine simbolo di quell’11 settembre di venti anni fa – restano indelebili nei nostri occhi.
Come per l’8 settembre e il 25 aprile, quando si parla di 11 settembre non c’è bisogno di specificare l’anno. Come tutti sanno che l’8 settembre è quello del 1943 e che il 25 aprile è quello del 1945, allo stesso modo è chiaro a tutti che l’11 settembre è quello del 2001. La tragedia che esattamente venti anni fa ha cambiato il mondo è diventata una data, oramai. E una sigla: 9/11, secondo l’uso anglosassone di anteporre il mese al giorno.
Un evento – il più grande e violento attentato terroristico, che causò la morte di 2.997 persone, più 19 dirottatori, e il ferimento di oltre 6.000 altre persone – entrato nella memoria collettiva dell’intera umanità e nei libri di storia, che ha cambiato non solo le relazioni politiche internazionali, la geopolitica, la politica estera, ma anche la vita di ciascuno, il modo di guardare gli altri, di viaggiare, di concepire la convivenza tra i popoli. Un vero e proprio spartiacque nel corso della storia, che ha segnato la distinzione netta tra un “prima” e un “dopo” a cavallo di quel tragico evento.
La ricorrenza dell’anniversario ci ripropone oggi quelle immagini, in un contesto segnato dalle gravi crisi – economica, politica, di slancio verso il futuro, nel pieno di una grave pandemia ancora in corso – in cui si dibattono gli Stati Uniti e l’intero Occidente, alle prese – tra l’altro – con un nuovo problema Afghanistan, dove sono tornati ad imperversare e a seminare morte e violenza i Talebani.
È questa la prospettiva da cui rileggere quegli eventi, le scelte corrette e gli errori che ne sono conseguiti, alla ricerca di indicazioni per reimpostare la nostra traiettoria storica, in un mondo sempre più intrecciato ed interconnesso di cui essere parte integrante.
Dei fatti dell’11 settembre 2001 siamo stati tutti spettatori, passivi e inorriditi: quattro aerei, decollati da differenti aeroporti della costa orientale degli Stati Uniti, vengono dirottati da 19 membri dell’organizzazione terroristica Al-Qaeda e fatti schiantare, con un attacco suicida, contro simboli economici e politici del paese: le Torri gemelle del World Trade Center di New York, il Pentagono a Washington. Solo il quarto aereo, grazie all’intervento coraggioso dei passeggeri, precipita prima di raggiungere il proprio bersaglio, probabilmente il palazzo del Congresso. Il bilancio finale fu di oltre tremila morti tra civili, forze dell’ordine, pompieri e dirottatori stessi, e di oltre seimila feriti.
L’attentato suscitò immediatamente emozioni fortissime, molto sgomento tra la gente, come ricordava l’allora presidente americano George W. Bush, dieci anni dopo, interpretando i primi sentimenti dei suoi connazionali: “Il 12 settembre, la gente, dopo essersi ripresa dallo shock iniziale, ha capito che quella che stavamo affrontando era una guerra diversa. Era una nuova realtà. Una delle cose che sono cambiate dopo l’11 settembre è la convinzione di essere un Paese protetto dagli oceani. In passato i conflitti erano avvenuti in luoghi remoti e noi ci sentivamo decisamente al sicuro. Era evidente che lo shock subìto fosse profondo. La gente aveva paura di andare al lavoro, di uscire di casa. Le compagnie aeree erano bloccate e le banche chiuse. La nostra società sotto certi aspetti era ferma. La cosa più importante da fare era riprendersi dagli attacchi” (“Il mio 11 settembre ora dopo ora”, in la Repubblica, 25 agosto 2011).
L’analisi delle reazioni dell’America all’indomani degli attentati fa emergere tre aspetti molto significativi. Innanzitutto la scoperta della propria fragilità, geografica ma non solo: gli americani si sono sentiti minacciati, indifesi, pervasi dal terrore di un nemico invisibile che può colpire in ogni luogo e in ogni momento, usando armi “non convenzionali” e del tutto imprevedibili. In secondo luogo, il moto di orgoglio che evidenzia la necessità di difendere i valori di libertà, democrazia e tolleranza, messi in discussione da un attacco violento e sanguinario, e che fa nascere una determinazione a combattere i terroristi che non è mai diminuita negli anni successivi. Infine, la ricerca di strumenti di protezione dei cittadini, dalle misure di sicurezza che tanto hanno inciso sulla vita quotidiana alla ridefinizione delle loro garanzie di libertà.
Tutto l’Occidente condivise pienamente le reazioni americane, così come ebbe modo di sperimentare il terrore degli attacchi terroristici in casa propria (come non ricordare, per gravità e conseguenze, l’attentato di Madrid dell’11 marzo 2004 – 192 vittime –, o quello di Londra del 7 luglio 2005 – 52 morti – o quelli di Parigi del 7 gennaio 2005 – allo ‘Charlie Hebdo’, 12 morti e 12 feriti – e del 13 novembre 2015 – al ‘Bataclan’, 130 morti) .
In Italia, l’allora direttore del Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli, intitolava così l’editoriale del 12 settembre: “Siamo tutti americani”, riassumendo efficacemente i sentimenti di tutti: “siamo paralizzati, increduli, partecipi, solidali a quanto accaduto al popolo americano”. E aggiungeva: “L’unica superpotenza rimasta si scopre, nell’era di Internet e della multimedialità create dalla propria tecnologia, debole e frastornata”. Come obiettivo dell’attacco e nel suo modo di reagirvi, dunque, l’America assurgeva a rappresentante dell’Occidente nel suo insieme.
Scoprirsi deboli, reagire, affermare la vitalità dei valori fondanti della propria nazione, proteggersi, sono reazioni immediate, ma che richiedono di tradursi in scelte, in leggi, in misure politiche: un’operazione che non è mai automatica o univoca. A distanza di venti anni da allora, ricordare l’11 settembre significa anche interrogarsi sull’adeguatezza dei mezzi impiegati nella reazione al fine che essi si proponevano e riconoscere dove si sono insinuate altre logiche o altre priorità.
Stando ad un resoconto di Philip Stephens, all’epoca opinionista politico del quotidiano londinese Financial Times, un alto funzionario statunitense avrebbe riferito, ad un gruppo di europeisti in visita a Washington nel 2003, i presupposti che reggevano le politiche americane di reazione all’11 settembre: gli USA avrebbero affermato la supremazia globale derivante dalla vittoria nella guerra fredda e la sicurezza dell’Occidente sarebbe stata ristabilita tramite una guerra lunga una generazione contro i jihadisti islamici. Un terzo presupposto era stato poi aggiunto dall’amministrazione Bush: il Medio Oriente sarebbe stato rimodellato a immagine della democrazia liberale occidentale. E aggiungeva: “ Tutto ciò prometteva una permanente egemonia degli USA, promulgava la dottrina della guerra preventiva e metteva da parte i limiti del multilateralismo. Non importava ciò che pensavano gli altri. Gli USA potevano agire unilateralmente” ("NO, 9/11 did not change the world”, in Financial Times, 1 settembre 2011). Ecco dichiarata la traduzione politica, tutt’altro che scontata, delle reazioni all’11 settembre: affermazione della supremazia degli Stati Uniti in una prospettiva unilaterale; identificazione dell’Occidente con i paladini della libertà e del mondo arabo-musulmano, senza tanti distinguo, con i nemici della democrazia; uso della guerra come strumento di diffusione della democrazia. È certamente comprensibile, ma non privo di problemi e conseguenze, scagliarsi contro il nemico “esterno”, “straniero”, senza chiedersi che cosa non vada in casa propria e nelle relazioni internazionali. Questi presupposti, a cui si aggiungono gli interessi economici, hanno determinato le decisioni successive, a partire dalle guerre in Afghanistan e Iraq.
Dopo venti anni, senza immagini eclatanti che lo testimoniano, ma forse non con meno vittime, il quadro dell’America è, per molti aspetti, quello di un Paese allo sbaraglio, come dimostra la caotica ritirata dall’Afghanistan. Un anniversario che, per ironia della sorte, cade 11 giorni dopo il ritiro dell’ultimo soldato americano dall’Afghanistan. Il 7 ottobre 2001, 26 giorni dopo i quattro attacchi suicidi, gli Stati Uniti invasero il Paese centro-asiatico, che ospitava la mente degli attentati: il leader di Al-Qaeda, Osama Bin Laden. L’obiettivo dell’invasione era distruggere Al-Qaeda, catturare Bin Laden e combattere la guerra al terrorismo. Osama Bin Laden è stato ucciso il 2 maggio 2011 (quasi 10 anni dopo gli attacchi alle Torri gemelle), Al-Qaeda è ancora attiva e la guerra al terrorismo è tutt’altro che vinta. Come ha scritto l’Economist, “Vent’anni fa l’America si era prefissa di rimodellare l’ordine globale dopo gli attacchi alle Torri gemelle. Oggi è fin troppo facile concludere che la sua politica estera è stata abbandonata su una pista dell’aeroporto di Kabul”. Al di là di tutti i discorsi sul declino e sull’isolazionismo americani, resta il fatto che dopo l’11 settembre ci sono state due grandi guerre in Medio Oriente, interventi USA e Nato in numerosi altri Paesi e l’ascesa di nuovi gruppi terroristici.
“Il mondo non ha più fiducia nella leadership americana. L’America non capisce il mondo. Capisce solo se stessa”. È l’amara riflessione di Mary Cardaras, già direttrice alla CNN e oggi docente universitaria titolare della cattedra di Comunicazione alla California State University, East Bay. "Dopo l’11 settembre – afferma la professoressa Cardaras – il mondo è molto cambiato. È un luogo meno aperto. Abbiamo paura gli uni degli altri. Siamo diventati più introspettivi e con lo sguardo rivolto verso l’interno. Penso che sia così perché, nel complesso le democrazie del mondo non sono riuscite a guidarci con successo attraverso le sfide poste dall’11 settembre. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, in particolare, penso che l’11 settembre abbia reso evidenti le debolezze del Paese. Anche se gli USA hanno superato la tempesta dell’11 settembre, hanno fallito nella loro risposta alla crisi. Lo vediamo, due decenni dopo, con i fallimenti in Irak e in Afghanistan. C’è bisogno di un riallineamento totale nel pensare alle democrazie, nonché alle loro risposte al terrorismo e alle minacce poste da militanti di qualsiasi tipo nei confronti dei cittadini laici. Le democrazie sono in difficoltà. Il terrorismo ha reso le democrazie più timorose di assumere un ruolo di guida, in termini di relazioni internazionali e di collaborazione. E credo anche che manchino leader capaci di produrre un cambiamento”.
La rilettura degli avvenimenti degli ultimi venti anni, compresa la crisi finanziaria scatenatasi nel 2008, e la più approfondita comprensione della globalizzazione ci hanno fatto capire la necessità di misure ben diverse da quelle adottate all’epoca dall’amministrazione Bush. Tutto converge sulla necessità di una governance globale, che non sia solo una nuova costruzione istituzionale, ma soprattutto un insieme di dispositivi politici, economici, sociali e culturali, in modo da permettere di riappropriarci tutti del processo di globalizzazione invece di subirlo: è la prospettiva di cui Benedetto XVI ha tracciato il profilo ideale nel n. 67 dell’Enciclica Caritas in veritate del 2009. Passare dall’ideale alla pratica non è un’impresa semplice, però. Oltre alla mancanza di una leadership per guidare il processo, è problematico immaginare il modo di prendere decisioni. L’esperienza mostra che negli organismi internazionali il processo decisionale è farraginoso e porta spesso a magri risultati. La governace, in ogni caso, non può essere la pura e semplice replica, su scala più ampia, di quella nazionale. Inventare un nuovo modello di governance internazionale è un salto maggiore in materia istituzionale.
Un ulteriore nodo è quello della legittimità, intesa come riconoscimento popolare: ogni processo di legittimazione si appoggia sulla prossimità, elemento del tutto assente tra le persone e il sistema internazionale. Mancando una prossimità geografica, l’unica strada per legittimare le istituzioni internazionali è il rinforzo del sentimento di appartenenza e quindi di solidarietà, fondato su una coscienza comune universale.
In questa direzione, una pista possibile è integrare le questioni globali alla vita politica e al dibattito pubblico nazionale (evitando le strumentalizzazioni), in modo da cominciare a percepire il coinvolgimento nelle vicende di ogni altro popolo e forgiare una sensibilità durevole alle prospettive comuni: dire “siamo tutti americani” (o iracheni o srilankesi o italiani) non può più limitarsi a circostanze eccezionali. Se i cittadini sono aiutati e formati a padroneggiare prospettive globali, possono poi sentirsi capaci di assumere iniziative q quel livello.
Anche i processi di integrazione (macro)regionale, come quello che l’UE rappresenta, hanno grande importanza nella costruzione di una prospettiva globale: beneficiano di una maggiore prossimità, anche se non di identità, dal punto di vista geografico, di valori, di cultura, e a volte anche di lingua. Lavorare insieme, prendere decisioni comuni, poco a poco erode la diffidenza propria delle relazioni internazionali. Le difficoltà in cui si dibatte oggi l’Europa nel gestire quanto di più concreto ha messo in comune (l’Euro) sono certamente comprensibili, ma richiedono di essere affrontate con coraggio e visione di lungo periodo.
Per questo è fondamentale mettersi a discutere onestamente di come superare le crisi e delle regole per crescere insieme. Il bene comune si ottiene valorizzando gli altri, non privilegiando il proprio egoismo. È questa la prospettiva con cui leggere i fatti dell’11 settembre, così come le crisi che si sono succedute nell’arco di questo ultimo ventennio, e nelle quali, per molti versi, ci siamo ancora immersi. Non c’è altra via per sconfiggere il terrorismo e la spirale di violenza che genera, per promuovere i valori di democrazia e libertà, per proteggere le persone in situazione di difficoltà. “La crisi – scriveva Benedetto XVI nel n. 21 della Caritas in veritate – ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive e a rigettare quelle negative. La crisi diventa così occasione di discernimento e di nuova progettualità”. Ma laddove si aprono delle opportunità, si apre anche il campo della responsabilità di coglierle.