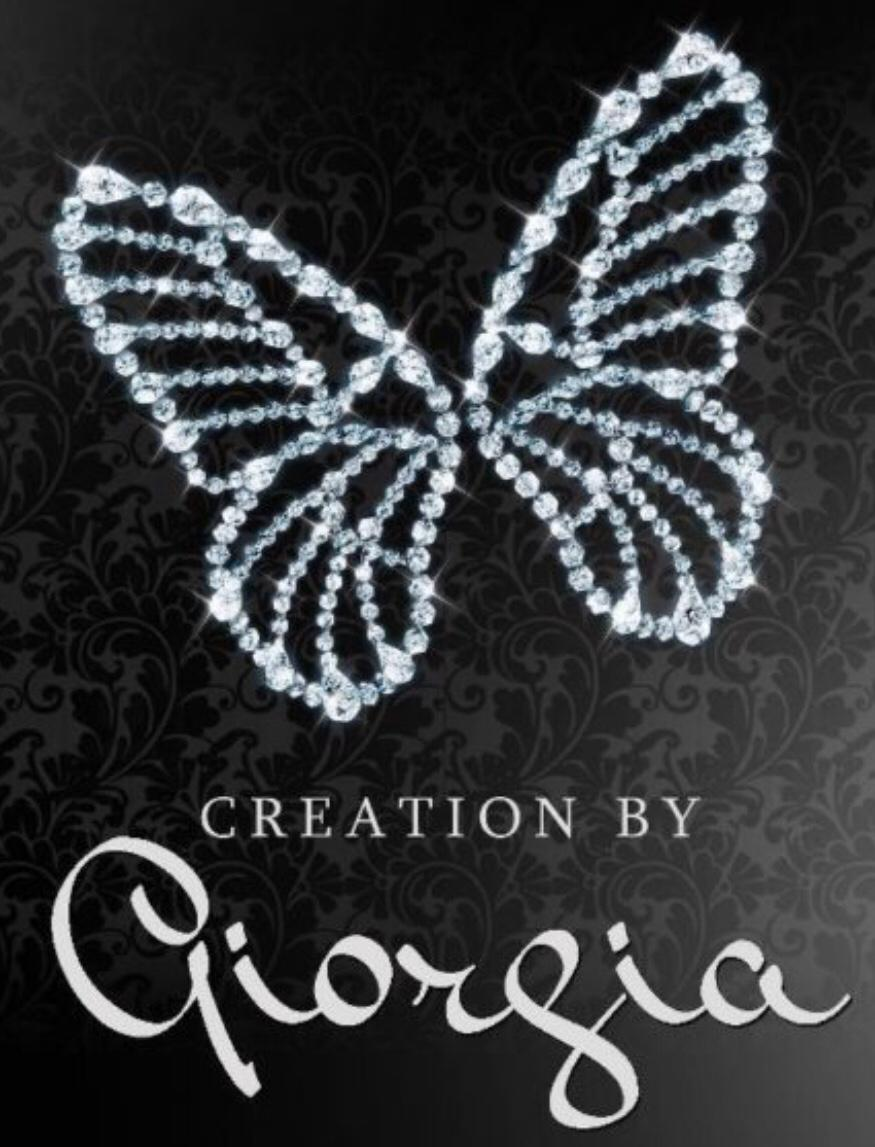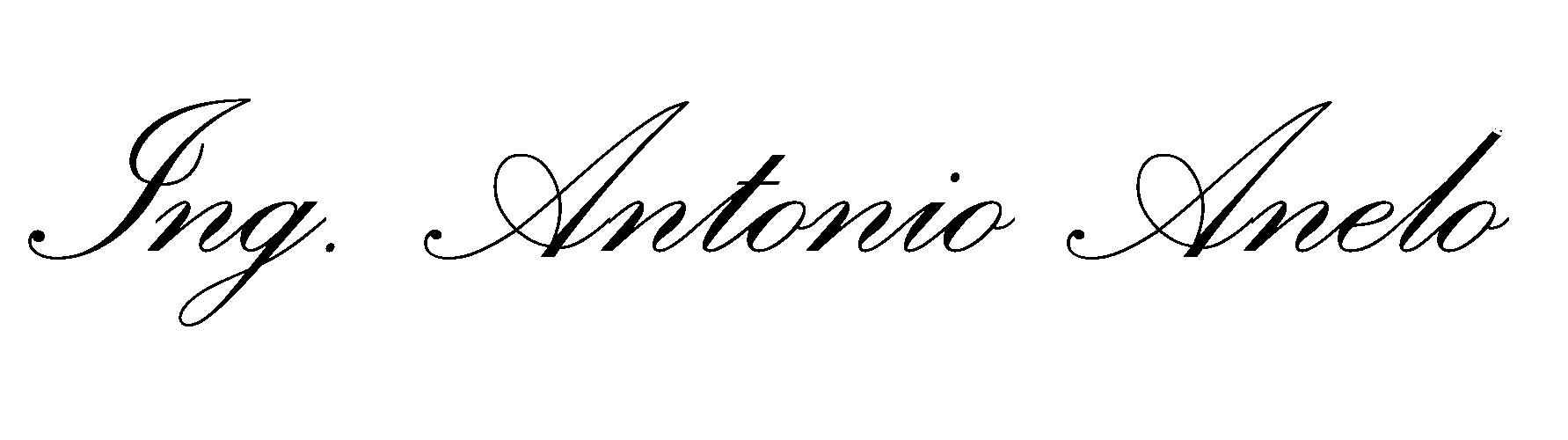di Massimo Reina
Ogni volta che un femminicidio si consuma, assistiamo al solito copione. Le notizie si rincorrono, i titoli si accavallano, e poi arriva il momento delle spiegazioni. Gli esperti si affannano a scandagliare la mente dell’assassino, a cercare una ragione per l’irrazionale. Ma quando la ragione non c’è? Quando la follia è lucida, premeditata, chirurgica? Il caso di Giulia Cecchettin non lascia spazio a dubbi: siamo di fronte a un orrore pianificato nei minimi dettagli, un crimine che va condannato senza se e senza ma.
La cronaca di un delitto annunciato
Le prove parlano chiaro. Gli indizi non sono solo inquietanti: sono un macabro manuale della premeditazione. Nulla è stato lasciato al caso, nessuna decisione è stata presa d’impulso. Chi compie un simile gesto non è una vittima delle circostanze, non è in balia delle emozioni. È un carnefice che ha avuto tutto il tempo di riflettere, pianificare e agire. In casi come questi, la parola “raptus” dovrebbe essere bandita dai vocabolari: non c’è nulla di improvviso in un delitto così calcolato.
Eppure, puntualmente, arrivano le attenuanti. La famiglia dell’assassino che parla di “un ragazzo problematico”. Gli amici che lo descrivono come “incapace di fare una cosa del genere”. Le solite analisi psicologiche che provano a trovare una giustificazione, un trauma, un disagio. Come se ogni crimine dovesse essere accompagnato da un’attenuante morale. Come se, alla fine, la colpa non fosse mai davvero dell’assassino, ma del sistema, della società, del destino.
Ma questa indulgenza non è solo offensiva per le vittime e le loro famiglie: è pericolosa. Perché ogni giustificazione, ogni attenuante, è un tassello che contribuisce a normalizzare l’inaccettabile. È un messaggio implicito che dice: "Non è davvero colpa sua". E così, il cerchio della violenza si chiude, e le statistiche continuano a crescere.
Ogni anno in Italia, decine di donne vengono uccise da partner, ex, conoscenti. Non sono numeri: sono persone. Sono vite spezzate da chi avrebbe dovuto amarle, proteggerle, rispettarle. E ogni volta, la narrazione si ripete: “Lei lo aveva lasciato”, “Non accettava la separazione”, “Era ossessionato”. Come se questo fosse sufficiente a spiegare, o peggio, a comprendere.
Condanne esemplari, senza alibi
La verità è che non basta più condannare questi crimini: serve farlo con fermezza esemplare. Ogni sentenza che lascia spazio al minimo dubbio, ogni pena che non riflette la gravità del reato, è un insulto alla memoria delle vittime e una tacita autorizzazione per chi potrebbe trovarsi a compiere lo stesso gesto. Non possiamo continuare a trattare il femminicidio come un “caso isolato”. Non possiamo relegarlo a un problema di salute mentale, a un disagio sociale, a un’emozione fuori controllo.
Chi uccide una donna che ha scelto di andarsene non è solo un assassino: è un simbolo di una cultura malata, che considera le donne come proprietà, come oggetti da controllare e, se necessario, da eliminare. E questa cultura, seppur personale e radicata in certi individui, si combatte con le parole, certo, ma anche con le azioni. Le condanne devono essere proporzionate all’orrore commesso, senza attenuanti, senza sconti.
Un cambio di paradigma
Ma non basta. Serve un cambio di mentalità. Serve un’educazione che parta dalle scuole, dalle famiglie, dai media. Serve un sistema di protezione che funzioni davvero, che non lasci sole le vittime quando denunciano, che non permetta agli assassini di agire indisturbati. Perché ogni femminicidio è un fallimento collettivo, e ogni vittima è una sconfitta per tutti noi.
Non c’è giustizia che possa restituire la vita a Giulia Cecchettin e ale altre vittime. Ma c’è un messaggio che possiamo mandare, forte e chiaro: chi commette un femminicidio non troverà mai giustificazioni, né clemenza dalla società. Perché l’amore non è possesso, e la libertà di una donna non è negoziabile. Non lo è mai stata, e non lo sarà mai.
Ma al contempo, evitiamo di perderci dietro parole vuote come “patriarcato”. In Italia, il patriarcato non esiste: è un’altra cosa, un sistema ben diverso da quello attuale. La prova è che casi come questi, pur nella loro atrocità, non sono migliaia, per fortuna, e quando accadono vengono denunciati e condannati pubblicamente. A farlo sono proprio gli uomini, quelli veri, che non tollerano questo tipo di violenza.
Trincerarsi dietro termini roboanti come patriarcato per fare audience o darsi un tono serve solo a distogliere l’attenzione dai veri problemi. Il focus deve essere sull’individuo da educare, o da fermare in tempo, non su una presunta società oppressiva. Perché il cambiamento inizia con l’azione, non con le parole, e con una condanna ferma che non lasci spazio a dubbi. Le vite spezzate meritano giustizia, non retorica.