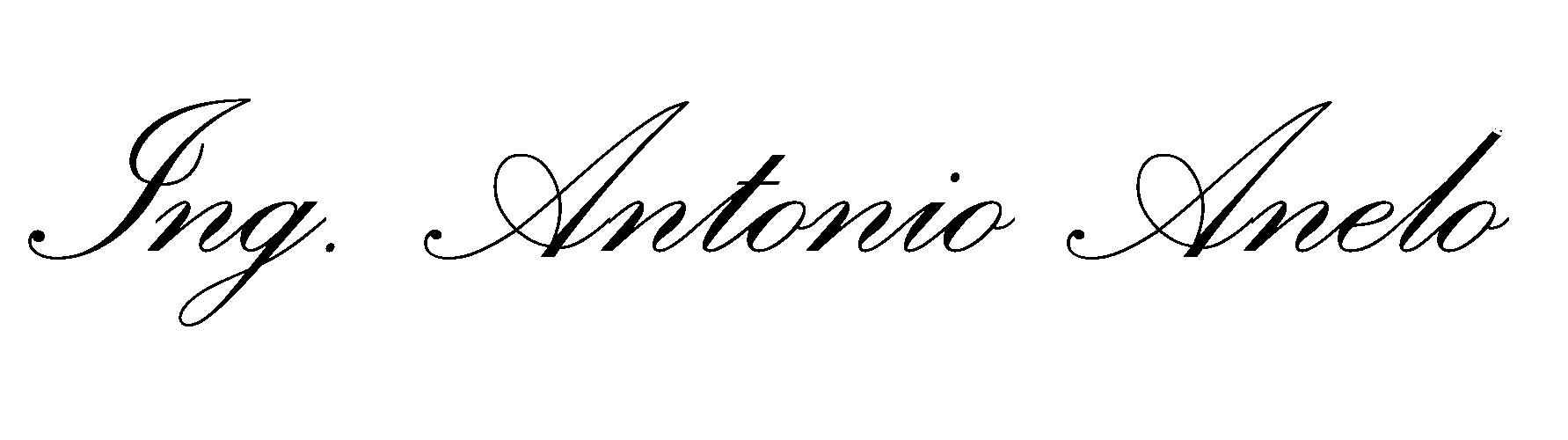PRIMO CLASSIFICATO

REINA MASSIMO
“FANTASMI DI ALEPPO”
Le vite sospese di uomini, donne e bambini tra le macerie del presente e le speranze per un futuro migliore
Avviene sempre così. La vita ha un modo curioso di intrecciare i fili del destino, di avvicinare i cuori e di stringere il cerchio della nostra umanità. Perché un fatto ci interessi davvero, perché tocchi le corde più profonde della nostra anima e si insinui nel nostro vivere quotidiano, è necessario che accada vicino a noi. Deve riguardare genti di cui abbiamo sentito parlare, che siano parte del nostro mondo, della nostra esistenza.
È un gran torto non essere conosciuti. Restare nell'ombra significa vivere nell'isolamento, avvolti da un silenzio assordante, intrappolati nel proprio dolore senza alcuna possibilità di ricevere aiuto o conforto. È una condizione che porta con sé un senso di vuoto e di abbandono, un'eco di disperazione che si riflette nelle notti insonni e nei giorni privi di luce.
Pensate a un piccolo paese nascosto tra le colline, lontano dagli occhi del mondo. Le storie di chi vive lì non raggiungono mai le grandi città, non vengono mai raccontate nei libri o nei telegiornali. Queste persone, con i loro drammi e le loro gioie, restano invisibili, relegati a una sorta di limbo esistenziale. Il loro dolore, che potrebbe essere grande quanto quello di un eroe tragico, rimane muto, sconosciuto, ignorato.
È come se il mondo avesse tracciato una linea, un confine invisibile che separa il noto dall'ignoto, l'importante dall'insignificante. Chi resta al di fuori di questo cerchio è condannato a una solitudine crudele, una solitudine che amplifica ogni sofferenza e ogni angoscia.
Non c'è conforto per chi è invisibile, non c'è salvezza per chi vive ai margini del racconto collettivo.
Per un popolo significa il lento dissolvimento, l’annientarsi progressivo di ogni vincolo internazionale, l’abbandono a se stessi, inermi e miseri di fronte a chi non ha altra ragione che la spada.
A scriverlo è Antonio Gramsci, uno dei più importanti pensatori del XX secolo, in un articolo pubblicato l’11 marzo del 1916 sul settimanale Il Grido del Popolo, ma sempre attuale.
Ma forse, in questo buio, c'è anche una sorta di terribile bellezza. La bellezza di chi lotta contro l'abbandono, di chi trova la forza di continuare a vivere e a sperare, nonostante tutto. È una resistenza silenziosa, una ribellione contro l'indifferenza del mondo.
Eccola Aleppo est, quella per anni sotto il controllo dei ribelli e teatro di scontri durissimi, quartiere Sheikh Saeed: palazzi sventrati dalle esplosioni, scheletri di cemento che si stagliano all’orizzonte.
Un pugno nello stomaco se si pensa che era uno dei centri più vivaci della Siria, la terza maggiore città cristiana del mondo arabo, dopo Beirut e Il Cairo.
Oggi è solo una cittadina piena di fantasmi, di gente che non c’è più e di spettri viventi risorti dalle ceneri di una tragedia recente e devastante.
Uomini e donne, giovani e vecchi, che si muovono tra le ombre del passato e le macerie del presente, determinati a non abbandonare ciò che era loro.
Sono anime invisibili che cercano disperatamente un segno di normalità in un mondo che ha smesso di essere normale.
Ma anche di un atto d'amore verso la città ferita, una dimostrazione di resilienza e affetto verso quei luoghi che un tempo erano stati pieni di vita e di gioia.
Nei loro gesti c’è una forza terribile e bellissima, una volontà di resistere che mi lascia senza parole .
Così ci sono Tarek e la figlia Qamar che hanno una bancarella davanti a quello che un tempo era il loro negozio, o Adad, uno dei tanti disoccupati di guerra diventato ambulante, che con una sedia, un rasoio e una bacinella d’acqua si è improvvisato barbiere proprio accanto ai ruderi della bottega di un coiffeur.
Per non parlare di Akram Fathi, che vende fagiolini e patate, e che tra quattro mura di pietra grezza che non riparano da spifferi e infiltrazioni, ha piazzato una poltrona e ricavato un salotto estemporaneo in quello che un tempo era un Internet Point, dove con la sua famiglia ha ritrovato una casa.
In un contesto così anche il più elementare dei gesti è un battito di vita, un grido silenzioso contro l'oblio, un atto di sfida contro la desolazione che minaccia di inghiottirli.
Quello che conta, in fondo, sono le piccole cose.
Poco più in là, per esempio, a poca distanza da un semaforo che funziona grazie all’energia solare, c’è un uomo che indossa una divisa da poliziotto mezza rattoppata. È solo, non può contare sul supporto dei colleghi e dei soldati russi che qui collaborano col regime per mantenere l’ordine pubblico, ma sembra deciso a far rispettare lo stesso la legge.
Alle sue spalle c’è il viale di accesso a un’area pericolosa, dove sta lavorando un bulldozer tra le strade appena liberate dalle rovine, pertanto non fa passare nessuno.
“E’ rischioso – dice, – è pieno di calcinacci e ci sono ancora frammenti di bombe inesplose”.
Tiene a bada diverse persone, famiglie con i figli piccoli, donne, anziani e ovviamente noi, il nostro interprete e i quattro miliziani di scorta.
Mi fermo a poca distanza, faccio un paio di foto con lo smartphone e osservo la scena da dove mi trovo.
Una scena terribile, più di quanto possa sembrare.
Basta solo mettere in moto la mente, ed ecco che il panorama assume un altro volto. Un volto più profondo e più drammatico di quanto già non appaia alla vista.
Ogni strada, ogni piazza, ogni pietra potrebbe raccontare una storia.
Ma non può parlare, e non c’è nessuno che può interpretarne correttamente i “segni”, quelli scavati da un proiettile o impressi nel cemento da un urlo disperato.
Chi ci viveva in questa casetta a due piani? Qualcuno ricorda se qui all’angolo c’era un negozietto di videogiochi o un panificio?
In quel vicolo ricolmo di macerie qualche coppietta ci avrà trascorso qualche attimo di intimità?
E ancora, com’era il sapore del caffè in quel locale di cui è rimasta in piedi solo l’insegna e il pezzo di parete a cui è attaccata?
Quali sono stati i muri delle fucilazioni?
Quanta la fame, la paura, la speranza di chi era nascosto dentro quella vecchia scuola diroccata?
Si trova a poche centina di metri da noi, dalla parte opposta. Bastano pochi passi spediti per arrivarci ed entrare nel cortiletto.
Tra le macerie di ciò che resta del piccolo parco giochi adiacente, l’immagine per me forse più disturbante, quella di giocattoli sepolti da polvere e macerie. E tra i detriti, un soldatino di plastica che emerge per metà da un mucchio di terriccio, simbolo di quella tragica ironia che a volte permea gli eventi più drammatici.
“Lui”, finto combattente “vittima” in una guerra reale, “morto e sepolto” dalle bombe di soldati veri.
Un rumore secco, uno stacco, e un pezzo di cornicione cade da un palazzetto a tre piani più avanti. Il poliziotto di prima si gira verso di noi, e con aria quasi compiaciuta esclama: “Visto?”. Perché anche in questo contesto in fondo, lui il suo dovere lo ha fatto. Crollano gli edifici, ma non la voglia disperata di normalità di questa gente, soprattutto tra i più piccoli.
Sono i bambini «fantasma», i figli non voluti, nati durante le occupazioni e le invasioni, da donne che sono state violentate e che ora li vedono come una vergogna. Altri sono "semplicemente" orfani, abbandonati a se stessi, senza nessuno che si prenda cura di loro o li protegga. Questi bambini portano con sé traumi inimmaginabili, come l'aver visto con i propri occhi un familiare ucciso, in casa o per strada, spesso in modo atroce.
Li vedo rincorrersi tra le macerie, con lo sguardo perso e i corpi troppo piccoli per il peso delle loro esperienze.
Ogni angolo, ogni frammento di ciò che una volta era una casa o un negozio, è per loro un ricordo di quello che hanno perso e di quello che non potranno mai avere.
Ne incrocio un gruppetto che gioca a palla tra uno spiazzo e i resti di una barricata che include un blindato bruciato.
Sporchi come spettri risorti dalle ceneri di un passato recente e devastante, indossano chi la maglia del Barcellona, chi del Real Madrid, dell’Al-Ittihad, di Hello Kitty o dei Pokémon.
Residui di una vita che fu, di quando qui, come nel resto del mondo, si guardavano le partite di calcio internazionale e nei negozi si potevano comprare i gadget delle squadre o dei videogiochi più importanti.
Samir non sa però delle ultime Champions vinte dal suo idolo Cristiano Ronaldo, né del suo passaggio alla Juve. Per lui il tempo si è fermato nel 2013: la guerra, la fuga verso il campo profughi di Jibreen e il ritorno ad Aleppo nel quartiere di Bustan al-Qasr, un’area della città a lungo priva di elettricità, di ripetitori e di una TV da guardare.
Haya, invece, forse nemmeno si ricorda più di Ash e Pikachu. Mi fa una certa tenerezza, con quella sua espressione timida e l’aria innocente.
Due occhi grandi e tondi a incorniciare uno sguardo limpido che rispecchia un animo fanciullesco dov’è ancora vivo lo stupore, la genuina capacità di meravigliarsi e di gioire di fronte alle piccole cose della vita.
Come un videogame, che in un secondo illumina i suoi occhi. “Mario!” esclama staccandosi dai compagni fermi attorno a noi: e mentre la mascotte di Nintendo saltella sullo schermo del mio smartphone in Super Mario Run, un altro ragazzino del gruppo, curioso e un po’ irriverente, ne approfitta per
chiedermi con l’aiuto dell’interprete cosa ci fa quel gioco nel telefonino di un uomo della mia età.
Mi domando quanti anni debbo sembrare di avere agli occhi di chi, in un lampo, si è visto sottrarre l’infanzia ed è dovuto diventare in fretta uomo per non farsi schiacciare dalla guerra.
Piccoli grandi eroi, a qualcuno dei quali hanno spento per sempre il sorriso con un proiettile, ma che non sembrano volersi piegare alla dura realtà.
E così, nel crepuscolo di questo pomeriggio, tra le ombre allungate e i muri sbrecciati di Aleppo, questi bambini diventano il simbolo di una città e di un popolo che, nonostante tutto, non vuole arrendersi.
SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO

DEL PRINCIPIO CONCEZIO
“PER DIRE: HO VISSUTO!"
È importante, anzi fondamentale per il bene del bambino, acquisire una piena e profonda consapevolezza del problema. Affrontarlo di petto, guardandolo negli occhi, prendere a due mani la vita e cercare di fare il massimo possibile per aiutare un figlio in difficoltà. Guai a chi prova a nascondere sotto il tappeto la polvere delle proprie insicurezze, a chi fomenta ed accresce la propria ipocrisia; guai a chi crede che il tempo possa risolvere il problema, a chi si sente responsabile di colpe che non ha; guai a chi fa finta di nulla nascondendo agli occhi degli altri la presenza di un notevole problema. Così facendo, paradossalmente ed inevitabilmente, si aiuta ad accrescere e ad aggravare le condizioni generali del figlio disabile. Avere un figlio portatore di handicap non è né una vergogna e né una colpa. Sono in primis i genitori a determinare col proprio comportamento l’esito evolutivo della malattia del figlio. Se non si provvede a chiedere collaborazione, a confrontarsi, a cercare di capire meglio, a vedere le cose da un altro punto di vista non si potranno mai ottenere circostanze, mezzi e persone che possano concretamente migliorare le condizioni di un figlio e neanche quelle proprie e della famiglia. Aprirsi agli altri è il modo giusto di affrontare i problemi, così da non lasciare nulla di intentato, senza il timore di vivere di rimorsi, ma con la certezza di aver fatto tutto, ma proprio tutto il possibile per rendere migliore la qualità di vita del figlio. È uno dei tanti insegnamenti avuti da Daniele. Daniele è un mondo meraviglioso. Mi regala un sorriso senza chiedere niente in cambio. Mi abbraccia stringendomi forte ogni sera prima di addormentarsi. Non ha bisogno di parole: aride e fredde parole che riempiono l’aria ma non colmano il cuore. É l’unico amore sincero, puro; non mi chiede che faccio per lui, è felice solo di avermi vicino. Mi tiene per mano ogni volta che usciamo di casa e vuole solo me e non mi lascia mai fino al ritorno. Non possiede il dono della parola. Fa salti di gioia quando torno dal lavoro e mi corre incontro abbracciandomi. A suo modo mi racconta la sua serenità che non è fatta di cose “firmate” e alla moda o di giocattoli nuovi ed unici, ma solo ed esclusivamente di affetto e di emozioni. Ama il mondo e tutte le persone che sono in esso; non nutre rancori né odio per nessuno. È un palloncino azzurro che vaga nell’aere tranquillo e beato, si adagia sulle correnti e si lascia trasportare. Meravigliandosi, osserva ogni cosa, sempre con distacco e dall’alto. Vive e volteggia nei soffi dell’amore che conosce da sempre e ci si trova bene. Ha la libertà prorompente di chi agisce senza ostacoli perché non li vede o, meglio, perché non esistono. È la libertà generata dall’amore per tutti. Non ha bisogno di sapere chi sei, ma solamente che ci sei. Un amore ripulito da reconditi interessi, da falsità e gelosie, da opportunismi e fragilità: un amore immacolato. Daniele è una barca sul fiume che naviga serena cullata dalle onde, osserva la natura che lo circonda, il sole che lo accarezza, la dolce brezza che lo sfiora. Rimane imperturbato se si alza il
vento, se l’acqua si increspa e fa sussultare la barca: Daniele rimane tranquillo perché ha fiducia in chi gli sta attorno, di chi ogni giorno provvede a lui in tutte le sue esigenze. Non ha mai contemplato la possibilità che l’uomo possa essere cattivo o minaccioso perché ha un animo candido e riesce, con la sua estrema sensibilità, a percepire l’ostilità, ad avvertire se le parole “ti voglio bene” sono sincere. Usa sorrisi, abbracci forti e vigorosi e intreccia le sue dita tra le mie per raccontarmi la sua gioia. Ed io divento ricco ogni giorno sempre di più, vivo delle emozioni che lui mi regala e mi sento la persona più fortunata del mondo. Ci ha insegnato cosa vuol dire vivere, quale senso ha, ci ha resi migliori, ci ha insegnato a guardare l’essenza delle cose, ci spinge ad andare oltre l’orizzonte per non impantanarci nelle banalità del quotidiano, ci insegna a capire il cuore dell’uomo senza condizionamenti esterni, e soprattutto ci ha fatto comprendere che la vita va vissuta e non subita, che l’opportunità della vita è contribuire a costruire sempre qualcosa di utile, di nuovo, di bello con la consapevolezza di aver dato il nostro sincero apporto all’umanità. E tutto questo Daniele ce l’ha insegnato senza parlare, senza mai proferire parola, ma solo con la purezza e la sincerità delle sue azioni. Il futuro non riusciamo a vederlo. Forse inconsciamente evitiamo di affrontare l’argomento. La vita ci spinge alle spalle, ci costringe a fare dei passi avanti. Camminiamo su una strada resa viscida dall’incertezza, verso un orizzonte nebbioso e indefinito. E la paura ci assale, allora abbassiamo lo sguardo verso il passo che compiamo quotidianamente cercando di non cadere in fallo, di restare dritti e sereni. Camminiamo sull’incertezza, verso un futuro non programmabile, verso la consapevolezza di non esserci più quando Daniele un giorno, spero lontano, avrà ancora bisogno di noi. Questo è il tarlo che divora la nostra mente, questo è il timore che ci assale: Daniele un giorno non troverà più il nostro aiuto, le nostre carezze, le nostre attenzioni, le nostre cure e tutto quanto possa preservarlo dal mondo malvagio e indifferente, crudele e insensibile. Tale paura è generata dalle poche, pochissime capacità cognitive di Daniele: la sua patologia non gli dà la capacità di comprendere cosa significhi aver dolore, o essere felice, o sentire freddo, o avere sonno, o essere stanco. Non lo sa. Conosce solo le cose concrete che vede e non le sensazioni, i sentimenti e tutte le situazioni emozionali. Confidiamo nella sua forza, nel suo magico istinto, nella bellezza dei suoi sentimenti. Non basta chiudere la porta della nostra casa per evitare situazioni cattive. E non possiamo rimanere sull’uscio di casa a guardare, spettatori inermi, cosa ci succede intorno. Quello che sta fuori ci appartiene, non è una cosa che riguarda solo gli altri, non è una cosa avulsa dalla nostra vita, che è fuori da noi ma, ci piaccia o no, è qualcosa che fa parte di noi. E tutto sarà migliore solo nel momento in cui, rendendocene conto, cominceremo a dare il nostro contributo, a metterci del nostro per cambiare le cose che non vanno, a cominciare a “giocare”. Dobbiamo finirla col delegare gli altri al posto nostro affinché possano risolverci la vita. Dobbiamo usare sempre e solo i nostri strumenti, che ogni individuo possiede fin dalla nascita, e modificare, migliorare il mondo intorno a noi. Non
bisogna lasciarsi andare, non bisogna che il resto sopraggiunga, ma bisogna impegnarsi a fare la propria parte, a condurre il gioco, a mettere in evidenza le proprie capacità. Tutto sarà possibile insieme al nostro possibile. Spesso penso che forse sono io il “disabile”, la persona che della vita non ha capito niente, immerso nel vivere quotidiano, anzi nel non vivere perché compiere quotidianamente quasi sempre le stesse cose, comportarsi sempre allo stesso modo non è vivere, ma abituarsi alla vita, non plasmarla, ma percorrerla, facendo sempre lo stesso giro. Sono convinto che nell’arco di un’esistenza, ciascuno di noi potrà dire di aver veramente vissuto SOLO pochi anni, perché purtroppo siamo sempre alla ricerca affannosa di cose frivole che ci fanno stare tranquilli, non ci destabilizzano, non ci creano disagio, non ci fanno uscire dalla confortante abitudine, che riempiono il nostro mondo materiale ma che inaridiscono il cuore e lo spirito. Daniele seduto, quasi immobile, sul divano: era l’immagine quotidiana che dovevo guardare, inesorabile e frustrante. Il mio cuore, oramai indolenzito dai continui schiaffi che riceveva da quelle statiche visioni, grondava di lacrime che sgualcivano e corrompevano la forza della speranza. Per Daniele hanno parlato gli occhi, per l’amore versato hanno parlato gli abbracci, per la voglia di riconoscenza hanno parlato le carezze. E abbracciato a lui, con lo sguardo nei suoi occhi, ho immaginato che, alla mia riflessione sul nostro rapporto, lui mi dicesse queste parole: “Senza parole tu ogni giorno mi ripeti: non parlare. Al sentimento non servono le parole: tu, non parlare. Ogni gesto ha il suo linguaggio: perciò tu non parlare. E io quanto amore riesco a darti senza mai parlare?! Tu fai come me: amami tantissimo senza parlare!” Se vuoi la serenità, cerca il sorriso di un bimbo; se vuoi un’emozione, cerca la carezza di un bimbo; se vuoi lo spirito colmo d’amore, cerca l’abbraccio di un bimbo e allora sì che potrai dire un giorno: ho vissuto!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PARADISO SANTINA
“UN BRUTTO TRASCORSO" (‘na mala passata)
Era il 1953 e per Vanninu arrivò il momento di prendere moglie. Aveva sott’occhio Pippinedda, una fanciulla di appena diciassette anni, molto attraente che, coi suoi occhi languidi e neri e i ricci capelli, gli faceva battere il cuore. Pippinedda aveva una sorella di sette anni più grande e meno bella di lei, Nunziedda, che aveva già l’età considerata, ai tempi, superata per prendere marito e in cui già si veniva considerate zitelle, ma sia il padre che la madre, Pinò e Maruzzedda, avevano già deciso di accasarla per prima, non solo per una legittima priorità dovuta all’età, ma anche perché dovevano sistemare una “macchia” che gravava sulla sua presunta illibatezza. Era tempo in cui la verginità aveva un valore religioso e morale e perderla prima del matrimonio era considerata una disgrazia, na mala passata (un “brutto trascorso”) e significava non trovare più marito. Nunziedda, nel luglio del 1943, aveva appena quattordici anni mentre la Seconda Guerra Mondiale imperversava e gli americani, da poco sbarcati sulle coste ragusane, avevano raggiunto anche il sobborgo di Cucucciuti (allodole capellute), nome dato dagli stessi abitanti a causa dei volatili presenti nella fauna del bosco vicino e per lo stile di vita che gli stessi conducevano, simile appunto alle allodole che trillano all’alba e si appollaiano presto la sera. Stanchi dal lavoro e stremati dalla fatica si adagiavano su un giaciglio di paglia, appena dopo l’imbrunire. Durante le incursioni belliche e i bombardamenti, il fischio degli esplosivi faceva confluire gli abitanti della borgata nelle vicine cave di pietra. Il pericolo, però, non era rappresentato solo dalle bombe e dai lupi che abitavano il vicino bosco, ma anche dai soldati dell’esercito americano che, soprattutto in preda all’alcool e dimentichi dei trattati, delle convenzioni e del diritto bellico, si avventavano sulle malcapitate fanciulle. I genitori, intenti nel duro lavoro dei campi, in quel luglio in cui i soldati sbarcando nelle vicine spiagge avanzarono verso l’interno della Sicilia, erano costretti ad allontanarsi dal focolare domestico, che nell’assenza veniva accudito dalle figlie femmine. Queste andavano ad attingere l’acqua in una fontana pubblica, detta biviratura a sugghità (bevaio in società), percorrendo a piedi una mulattiera lunga quasi un chilometro, con l’anfora di creta appesa al braccio. In questo camminamento Pippinedda, mentre verso l’ora del tramonto faceva ritorno al casolare, con la sua anfora stracolma d’acqua, si trovò violentemente avvinghiata da un soldato americano che ubriaco e assetato di carnalità non esitò un attimo nel suo intento. La trascinò sotto un carrubo, a poca distanza dalla strada e dopo qualche ora l’abbandonò sul viottolo, senza ritegno e senza pietà, ferita e infangata. La sera percorreva quel tratto di strada sterrata massaru Ianu che col suo carretto trasportava pietrame dalla vicina cava di pietra. Fu il cavallo che sentendo un pianto misto a un lamento puntò i piedi e non volle proseguire. Massaru Ianu la riconobbe subito. La trasportò al casolare, dove la mamma appena rientrata, con un mannello di spighe da far sgranocchiare alle galline, avendo subito intuito quanto accaduto si mise subito a urlare e a imprecare contro i soldati, la malasorte e contro la stessa figlia, vittima e colpevole, dicendole che a quell’ora ad attingere l’acqua non ci doveva andare. Poi dopo aver fatto giurare a Massaru Ianu di non proferire parola alcuna con il vicinato e soprattutto col marito, andò a prendere la bagneruola di zinco e, continuando a ripetere chi mala passata! lavò il fango della povera sventurata e disinfettò le ferite con l’aceto. Terminata l’operazione si fece promettere dalla figlia di non dire niente al padre, giustificando la cosa col fatto che quel pover’uomo aveva già tanti problemi per la testa e non si sa come avrebbe reagito all’accaduto. Turi era infatti molto geloso delle proprie donne. Una
volta che i vicini per il Natale organizzarono una festicciola di ballo in casa, al suono di fisarmonica, chitarra e mandolino e Tanu l’aveva invitata a ballare, intanto che qualche bontempone spense la lumiera, il padre preso dal panico implorò: Tanu batti i manu (Tano batti le mani), a conferma che quelle mani non potessero osare sul corpo giovane e casto di Pippinedda. Nessun uomo doveva avvicinarsi alla sua casa, soprattutto in sua assenza. Attorno all’abitazione aveva piantato filari di ficodindia. Dopo qualche mese dalla violenza subita Pippinedda avvertiva capogiri e aveva disgusto per il cibo. La mamma anche questa volta intuì: Nunziedda era incinta. Stavolta bisognava proprio dirlo al marito, non c’era alternativa. Turi urlò, s’infuriò e bestemmiò. Alla fine, entrambi convennero di non fare uscire la figlia da casa per tutto il corso della gravidanza. Con i vicini avrebbero inventato qualche scusa. La tennero, così, segregata e rinchiusa in casa per tutto il periodo. Nunziedda diede alla luce un bel maschietto, ma non glielo fecero neanche vedere perché subito venne portato in orfanatrofio e il segreto venne ben celato dentro le mura domestiche.
Vanninu aveva già il suo podere e il carretto con la mula. La guerra era già finita da otto anni: era il momento propizio per chiedere la mano di Pippinedda. Tramite il “messaggero” recapitò la proposta ai genitori che fiutarono subito l’attesa opportunità. Dissero a Nunziedda che un’occasione simile non si sarebbe più ripresentata. Del resto con quella mala passata non poteva aspirare ad altro; doveva ritenersi proprio fortunata. Bisognava ancora una volta nascondere la verità e pertanto Pippinedda non venne neanche consultata. Mandarono, pertanto, a dire che la figlia disponibile era Nunziedda, quella che volevano “sistemare” per prima, a tutti i costi. Vanninu, però, preso com’era, non volle sentire ragioni. Oltretutto Nunziedda non era di piacevole aspetto. La famiglia a questo punto diede l’apparente assenso per il fidanzamento di Pippinedda, che durò appena tre mesi, ma in effetti meditava altro. I figli a quei tempi dovevano essere accondiscendenti alle decisioni dei genitori che trattavano direttamente col messaggero. Spesso le figlie conoscevano il futuro marito solo all’atto del fidanzamento. I legami familiari degli abitanti di quella piccola borgata rurale erano di tipo patriarcale e il rispetto per i genitori e gli anziani era la prima regola di comportamento. Iniziarono così i preparativi per il matrimonio. I genitori si occuparono personalmente del disbrigo dei documenti e fecero in modo che il nominativo risultante dagli atti fosse quello di Nunziedda, la sorella maggiore. Vanninu si accinse, pertanto, a sposare Pippinedda, o almeno pensava di farlo. Il matrimonio venne celebrato di prima mattina nella chiesa della vicina borgata di Piano Campana, dopo aver percorso a piedi il lungo sentiero polveroso. I festeggiamenti, con i pochi familiari, si svolsero nella casa dei genitori della sposa, con un pranzo a base di pasta ncasciata (incassettata) e galline ripiene a brodo. Nel pomeriggio continuarono, tra contraddanze e tarantelle, ritmate da un organetto suonato dal fratello dello sposo, dolci di riposto e “calia” e durarono fino a sera. Il tutto fu accompagnato da abbondante vino e rosolio che lo sposo bevve in quantità. A riempire il bicchiere, suggerendo un brindisi, era sempre il padre di Pippinedda, incitato dalla moglie. Ai tempi le abitazioni venivano ancora illuminate con il lume a petrolio, lusso consentito però solo ai più benestanti, o con la candela a olio o lumiera (lumera), quest’ultima utilizzata a casa di Turi, in cui era stava ricavata una stanza per i novelli sposi. Quando tutti andarono via, i genitori, insieme a Nunziedda, accompagnarono gli sposi fino alla stanza nuziale, per un ultimo saluto alla figlia ormai maritata, e nell’atto di augurare la buonanotte soffiarono sulla candela a olio. Nel buio, però, i genitori lasciarono Nunziedda, complice del raggiro, e con una scusa allontanarono Pippinedda, chiudendo bene la porta. Vanninu, sotto l’effetto della sbronza, cadde sul letto come una pera matura. La mattina dopo non ricordava neanche in quale letto avesse passato la notte. L’ingenuo sposo si accorse solo alla luce del giorno, passata la sbornia, dell’incredibile cambiamento di fattezze e di come era stato beffato, ma ormai era troppo tardi per rimediare! Nunziedda, istruita bene dalla madre, lo convinse che il matrimonio era stato consumato e per dare dimostrazione di
questo alle pettegole vicine, l’indomani di buon mattino stese perfino le lenzuola nuziali in bella mostra. Esibivano il segno dell’illibatezza, procurato con un’ingannevole spina di rovo.
Tanu voleva conto e ragione dalla suocera ma questa, con aria soddisfatta, gli disse: cosi o scuru a ghiuornu parunu! (Le cose fatte al buio si vedono bene alla luce del giorno!).
Non passò molto tempo e Nunziedda morì. Solo allora venne coronato il sogno d’amore di Pippinedda.
TERZO CLASSIFICATO EX AEQUO

MODICA GIUSEPPE
“LA VENDITRICE DI GERBERE"
In un piccolo paese, situato ai piedi di un'altura che lo proteggeva dalle avversità atmosferiche, composto per lo più di case basse che ornavano una sola strada, abitava un'anziana donna, sola, poiché il marito era deceduto per aver contratto una malattia rara, della quale nessuno le aveva dato spiegazioni; era morto e basta. La signora, poverina, che ancora non percepiva nessun sostegno pensionistico, a causa delle lungaggini burocratiche che si erano susseguite dopo la morte del marito, era stata costretta, pertanto, ad inventarsi una attività con la quale poter guadagnare qualche euro per vivere.
Le era rimasta solo la casetta in pietra posizionata all'uscita del paese, ed un appezzamento di terra che già coltivava con ogni tipo di ortaggi per sbarcare il lunario. Ebbene, quel fazzoletto di terra le aveva consentito di avviare una modesta attività legata alla coltivazione di fiori, precisamente le Gerbere, grandi margherite di svariati colori; questo tipo di fiore lo aveva sempre amato, soprattutto perchè amava tutte le tinte pastello che ogni fiore assumeva. La signora, non avendo avuto figli, aveva persino raccomandato ai vicini che in caso fosse andata via, per raggiungere il suo amato marito, desiderava quale ornamento sul feretro, appunto, un mazzo di Gerbere tutte di colore diverso.
Ma torniamo alla sua nuova e modesta attività. Utilizzando la zappa del povero marito, aveva dissodato la parte di terreno più vicina alla casa, ed aveva messo a dimora almeno duecento giovani piantine di Gerbere, comprate con una parte dei già pochi soldi che le aveva lasciato il coniuge, depositati in un Ufficio Postale ubicato nel paese vicino, poichè nel suo non vi era tale servizio.
Ogni giorno, l'anziana, annaffiava tutte le piantine con un tubo giallo cotto dal sole e sul quale aveva riparato con del mastice alcuni buchi, per evitare di sprecare acqua preziosa ma, soprattutto, per non comprarne uno nuovo.
Guardava la sua coltivazione felice, ed aspettava paziente che comparissero le prime margheritone colorate. Curava ogni piantina con lo sguardo amorevole di chi guarda crescere un figlio.
Finalmente, dopo tanta attesa, arrivò il giorno in cui poteva raccogliere i suoi fiori per cercare di venderli ai suoi paesani.
Le sue rughe si potevano contare, sembravano strade acciottolate, calpestate da milioni di passi. Tutti i giorni poneva la sua sedia impagliata con corda d'agave, quasi nascosta dallo spigolo d'una casa vecchia quanto lei, attingeva qualche litro d'acqua dalla polla d'ottone presente nelle vicinanze e vi immergeva, con cura, mazzetti di Gerbere colorate.
Si legava sotto il mento i lembi di un fazzoletto che copriva la chioma canuta, ed aspettava immobile che qualquno si fermasse ad acquistasse i suoi fiori.
In verità, molti paesani si fermavano ad acquistare le sue Gerbere colorate; chi per ornare la sua casa, chi per portarli sulla tomba di un parente, ed alcuni, forse, solo per far si che la donnina potesse racimolare qualche soldo per andare avanti.
Dalla fermata del bus la guardavo, ogni mattina, e lei incrociando il suo sguardo col mio, sorrideva appena.
In quell'angolo di via, su quella sedia annosa, vedevo mia madre, quando posava il suo corpo stanco sotto il pergolato.
Non comprai mai i suoi fiori, non possedevo un vaso e non avrei saputo a chi donarli. Avrei, però, comprato il suo sorriso.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PELLICCIOTTA ALDO
“CUORE D'ORO"
In un paese piccolo e povero viveva una famiglia che era la piu' misera e bisognosa: mamma, papà e un bambino. Mesti ed indigenti essi vestivano di stracci e spesso non avevano nulla da mangiare, né i vicini potevano dar loro qualcosa giacché non ne avevano abbastanza neanche per essi stessi. Quando nevicava, mentre gli altri piccoli erano contenti e giocavano con la neve, Emanuele (così si chiamava il bambino), era triste ed infreddolito perché non possedeva né il cappotto né le scarpe. Un giorno suo papà, che per tirare avanti svolgeva lavori saltuari, ammazzandosi di fatica ma con scarso salario, incontrò il parroco che gli disse: “Sai, ho saputo che in Sardegna c'è una richiesta di minatori, sarebbe una buona occasione anche per te, potresti guadagnare una paga mensile fissa così da poter aiutare la tua famiglia”. L'uomo annuì, tornò a casa e ne parlò con la moglie, decisero che sarebbe andato. La compagnia mineraria anticipava il costo del viaggio che sarebbe stato, poi, restituito a rate, un po' al mese.
Un bruttissimo pomeriggio di marzo, con il cielo plumbeo, sotto un temporale insistente accompagnato da forti folate di vento, l'uomo abbracciò la moglie, baciò il figlio sulla fronte, e mentre le lacrime che scendevano copiose sul viso di tutti e tre si mischiavano e confondevano con la pioggia, con le spalle curve, stringendo in mano una patata e una cipolla, il suo cibo da consumare durante il viaggio, si incamminò verso la vicina stazione ferroviaria. Mentre la locomotiva correva, egli si affacciava al finestrino per individuare qualcosa che lo potesse indirizzare verso casa, e dapprima fece riferimento al campanile, scomparso quello dalla vista, rimirava la collina che sapeva fare da sfondo alla sua casupola, poi guardò la montagna che l'accompagnò per un lungo tratto. Giunto a Civitavecchia, la sera si imbarcò su un traghetto, lui che non aveva mai visto il mare! La sua notte a bordo fu popolata di ricordi, ripensava alla sua fanciullezza, quando il nonno lo conduceva a pascolare l'unica capra che possedevano, e intanto che l'animale brucava la scarsa erba, gli insegnava a ricavare uno zufolo da una canna; a quando suo padre piantando un bastone nel terreno, a seconda della lunghezza dell'ombra che esso proiettava, intuiva che ora fosse, a quando sua madre, di sera, gli accarezzava i capelli e gli cantava una nenia per farlo addormentare sereno e protetto.
Appena i suoi occhi provavano a chiudersi per la stanchezza
del viaggio, gli incubi prendevano il sopravvento sui ricordi e gli apparivano ceffi bruttissimi che cercavano di rapire la moglie e il figlio, ed allora riapriva gli occhi di soprassalto ed il suo cuore accelerava i battiti, la fronte si imperlava di goccioline fredde e la schiena era piena di sudore. Finalmente fu giorno e l'uomo, stropicciandosi gli occhi cercò di guardare da tutti i lati della nave per scorgere la montagna, quella che gli rammentava casa, ma da qualunque direzione guardasse fino ad arrivare alla linea dell'orizzonte, vedeva soltanto una enorme distesa d'acqua: capì, allora, di essere solo per la prima volta. Solo, senza famiglia, senza parenti, senza amici, senza paesani, solo con se stesso e con i suoi pensieri. Sbarcò e la sera giunse alla miniera. Fu alloggiato in una baracca di legno insieme ad altri venti operai, avrebbe iniziato il lavoro il giorno dopo. Così fu, scese per la prima volta nel ventre della terra umida e calda per cavare carbone con un casco di protezione al quale era appeso un lume alimentato ad acetilene, questo era necessario per vedere ma anche perché avrebbe potuto salvargli la vita. Infatti se la fiamma si fosse spenta avrebbe segnalato la mancanza di ossigeno ed il conseguente pericolo di grisou, il terribile gas delle miniere molto infiammabile e detonante. Oltre al gas, altri percoli erano rappresentati da crolli nelle gallerie e soprattutto dalla polvere di carbone che si insinuava nei polmoni provocando la silicosi. Per limitare la polvere i minatori avevano in dotazione una maschera, ma essi spesso la toglievano perché dava fastidio ed era troppo calda sul viso. Il papà di Emanuele, sarà perché magro e macilento, sarà perché sottoalimentato, sarà perché sempre abituato all'aria aperta, dopo alcuni mesi si ammalò e fu ricoverato in un ospedale con una diagnosi molto seria che gettò nello sconforto la moglie e il figlio. La donna, oltre che al bambino, doveva accudire anche il suocero anziano e malaticcio e pertanto non poteva muoversi dal villaggio, allora Emanuele decise di partire lui per stare accanto al padre. Un vicino di casa inchiodò alcune strisce di cuoio a due pezzi di legno che gli legò ai pedi a mo' di zoccoli, in modo da non camminare a piedi nudi. Emanuele si allontanò dal paese con il coraggio della disperazione, si trattava di suo papà, e ad ogni costo doveva raggiungerlo e salvarlo. Quando arrivò vicino al letto trovò il padre ad occhi chiusi e con il respiro affannoso, lo chiamò, lui si girò, aprì gli occhi e vedendolo, con un filo
di voce disse: “Emanuele,Emanuele mio”. E scoppiò a piangere singultando in un pianto sommesso. Anche il bambino pianse senza farsi vedere, ma insieme ad Emanuele, sulla sua spalla era giunto anche il suo Angelo Custode che era lì per aiutarlo e proteggerlo e gli disse: “Emanuele, non piangere, tuo papà si salverà, ha bisogno di una cura lunga e costosa ma si salverà”. In quel momento il degente che era vicino di letto ebbe una crisi ed aveva bisogno immediato di una trasfusione di sangue del gruppo AB-negativo, molto raro. Subito Emanuele si fece avanti coraggioso ed altruista, e disse al dottore che lui sarebbe stato disposto a donare se il suo sangue fosse stato compatibile. Le analisi accertarono la compatibilità e la trasfusione fu effettuata. Il giorno dopo il paziente aveva superato la crisi e seppe che doveva la vita al bambino, lo chiamò a sé e gli disse cosa avesse potuto fare per sdebitarsi, Emanuele gli chiese di aiutare suo papà a guarire. Quell'uomo era ricco e fece ricoverare a sue spese il papà del bambino per lungo tempo in un sanatorio e quando fu guarito gli diede un posto di lavoro come giardiniere nella sua villa nella quale si trasferirono in famiglia e vissero tutti felici e contenti per il resto della loro vita.