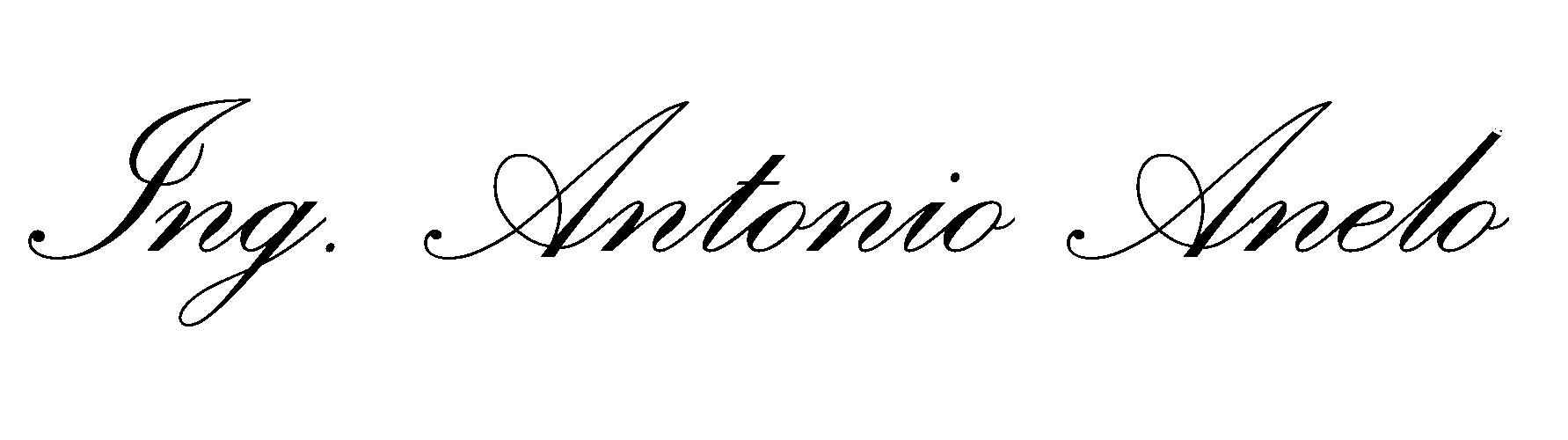di Massimo Reina
Viviamo nell’epoca in cui il giornalismo, quello vero, quello che dovrebbe informare, denunciare e raccontare senza filtri, è stato sostituito da un circo di pseudo-giornalisti che si credono star, pronti a tutto per una manciata di visibilità, un contratto più remunerativo o magari un invito in prima serata.
Un tempo si rischiava la vita per documentare una guerra o un regime. Oggi si sfiora il dramma, rigorosamente circondati da tutti i comfort, facendo attenzione a non sporcarsi troppo la camicia di lino. Non si documenta più la realtà: si studia il miglior modo per sfruttarla. Un bombardamento, una tragedia, una carestia: ogni evento diventa un palcoscenico per mettere in scena se stessi.
Nel 1993 il fotoreporter sudafricano Kevin Carter immortalò un bambino sudanese accasciato a terra, stremato dalla fame, con un avvoltoio alle sue spalle in attesa della fine. Una foto che fece il giro del mondo, gli valse il Pulitzer e lo consegnò alla storia. Ma a che prezzo? Quando in una trasmissione radiofonica dove era ospite gli chiesero che fine avesse fatto quel bambino, rispose candidamente: "Non lo so, ho aspettato una decina di minuti che l’avvoltoio si alzasse in volo per farne un’altra più drammatica, ma non lo ha fatto. Quindi sono andato via di corsa, avevo un aereo da prendere". La risposta di un ascoltatore fu brutale: "Quel giorno c’erano due avvoltoi: uno aveva una macchina fotografica". Carter, tormentato dal dubbio, finì per suicidarsi un anno dopo.
Eppure, nonostante il tragico epilogo, la lezione non è servita. Ancora oggi abbiamo gente che si crede "giornalista", ma lo sono solo nella loro fantasia, blogger figli di papà che possono permettersi di inventarsi un “lavoro” e viaggiare, paladini dell’informazione improvvisati che dalla cameretta di casa si lanciano improvvisamente nei teatri di guerra, o meglio, nelle vicinanze, solo per qualche scatto strategico, con l’esercito di assistenti, fixer e traduttori sempre a portata di mano.
Vanno là dove fa comodo, stazionano nei pressi di un campo profughi o in una capitale dove vige un certo regime, magari sperando in un arresto ad hoc che possa trasformarli in martiri della libertà di stampa. Non cercano la verità, ma il titolo che faccia notizia.
Si vantano di essere in prima linea, ma mai troppo vicini da sporcarsi di sangue. Quella è una cosa che magari lasciano fare alle troupe locali, ingaggiate per pochi spiccioli e mandati al fronte a riprendere la guerra, mentre loro se ne stanno comodi in qualche hotel o base militare a chilometri di distanza, a fare selfie taroccati mentre aspettano filmati e informazioni dal fronte.
Basta una foto col tizio con un kalashnikov in mano, un'intervista a un miliziano qualunque e il gioco è fatto: la notizia è servita, pronta per essere condivisa sui social e per far impennare gli indici di ascolto. Ma dietro a queste immagini patinate e a queste storie emozionanti, si nasconde una realtà ben diversa.
Raccontano la tragedia, ma il loro vero obiettivo è il clamore. Una narrazione studiata per essere virale, un dolore costruito a tavolino per fare audience. E intanto le vere vittime, quelle che non hanno contratti milionari con i grandi media, restano invisibili.
“Giornalisti” da cameretta
Simili, ma forse peggiori, quelli che figli di papà non sono e non possono pagarsi un viaggio all’estero per fingere meglio, ma ci provano lo stesso con reportage... dalla cameretta di casa!
Quanti di questi “reporter da poltrona” hanno davvero messo piede in una zona di guerra? Quanti hanno rischiato la vita per portare alla luce la verità? Temo pochi, pochissimi. La maggior parte si limita a riciclare comunicati stampa, a copiare notizie da agenzie di stampa e a inventare dettagli per rendere più accattivanti i loro reportage.
Eppure, questi "giornalisti" vengono osannati come eroi, premiati e intervistati in tv. Ma eroi di cosa? Dell'ipocrisia? Del conformismo? Del buonismo da salotto?
Certo, è importante informare i cittadini su ciò che accade nel mondo. Ma è altrettanto importante farlo con onestà, con rigore e con un pizzico di sana critica. Non possiamo permettere che la guerra diventi uno spettacolo da consumare comodamente a casa, un prodotto da vendere al pubblico come qualsiasi altro bene di consumo.
I veri reporter di guerra sono quelli che mettono a rischio la propria vita per portare alla luce le atrocità della guerra, quelli che denunciano i crimini di guerra, quelli che danno voce ai senza voce. Non sono quelli che si limitano a raccontare una storia già scritta, a confermare un'opinione precostituita.
Quindi, la prossima volta che vedrete un reportage da una zona di guerra, fatevi qualche domanda. Chiedetevi chi c'è dietro a quella telecamera, quali interessi rappresenta, quale verità sta cercando di nascondere. E soprattutto, chiedetevi se davvero avete bisogno di un altro selfie con un kalashnikov per capire cosa sta succedendo nel mondo.
Il giornalismo non dovrebbe essere un reality show. Non dovrebbe sfruttare la sofferenza come un set cinematografico. Perché la linea tra il raccontare e il lucrare sulla tragedia è sottile. E troppi, oggi, l’hanno già attraversata.