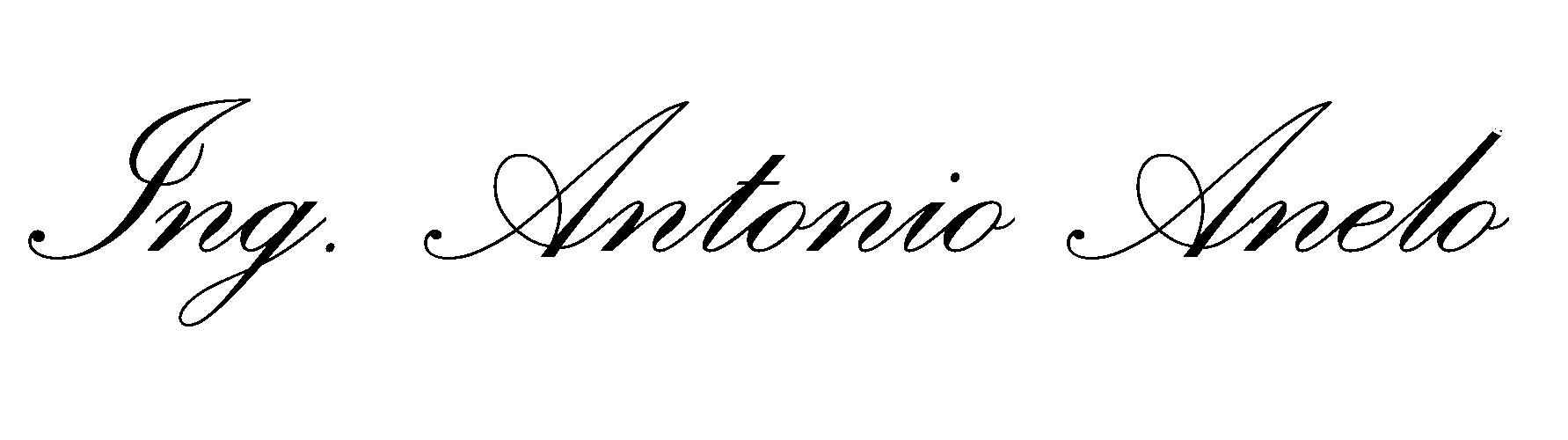di Massimo Reina
Viviamo in un Paese che, tra leggi fatte male e applicate peggio, riesce a trasformare ogni dramma sociale in un groviglio di burocrazia e ambiguità. Prendiamo lo stalking, quel reato che il Codice Penale definisce con il pomposo termine di "atti persecutori" (articolo 612-bis), ma che, nella vita reale, si traduce in molestie costanti, violazioni della privacy e paura. Un incubo quotidiano per chi lo subisce. Ma ecco la domanda: perché, per configurare lo stalking, nel 90% dei casi viene chiesto alla vittima di dimostrare che ha cambiato le proprie abitudini di vita?
Il Codice e il buon senso (che manca)
Secondo la legge, lo stalking si verifica quando le condotte persecutorie dell’autore provocano uno di questi effetti:
Un grave stato di ansia o paura.
Un fondato timore per l’incolumità propria o altrui.
Un cambiamento delle abitudini di vita.
Fin qui, tutto sembra chiaro. Non è obbligatorio che si verifichino tutte e tre le condizioni; basta una sola. Ma, nei fatti, il nostro sistema giudiziario sembra ossessionato dal punto numero 3: il cambiamento delle abitudini. Perché? Perché è l’unico criterio tangibile, misurabile, dimostrabile con prove concrete. Peccato che questa logica da ragionieri cancelli con un tratto di penna le sfumature della vita reale.
La vittima deve cambiare abitudini?
Chiedere a una vittima di stalking di dimostrare di aver cambiato le proprie abitudini per essere creduta è un insulto al buon senso. Perché? Perché non tutte le persone reagiscono allo stesso modo. C’è chi smette di uscire da casa per paura di incontrare il molestatore, e chi invece, per forza di carattere o necessità, cerca di mantenere una parvenza di normalità, pur vivendo nel terrore.
Cosa facciamo con quest’ultima categoria? Le ignoriamo? Diciamo loro: "Ah, ma non hai cambiato il tuo numero di telefono? Allora non è così grave!" Oppure: "Sei ancora al lavoro? Non puoi avere paura davvero."
È assurdo. È come dire che per essere vittima di un’aggressione fisica, devi dimostrare di essere finito in ospedale, altrimenti non conta.

Una legge che non tutela
Il problema è che la legge sullo stalking, introdotta con la legge n. 38 del 2009, è nata con l’intenzione di tutelare le vittime, ma è stata scritta male. Il concetto di "cambiamento delle abitudini" è finito per diventare un pretesto per minimizzare o, peggio, ignorare il dramma delle vittime. Perché in un’aula di tribunale è più facile parlare di "prove oggettive" che entrare nella complessità psicologica di chi vive nel terrore quotidiano.
E poi c’è il paradosso tutto italiano: mentre le vittime devono dimostrare di aver cambiato vita per essere credute, gli stalker sanno benissimo che il sistema li protegge. Denunce archiviate, ammonimenti inefficaci, processi che durano anni. Nel frattempo, la vittima continua a vivere nella paura, o forse a non vivere affatto.
Questa ossessione per il "cambiamento delle abitudini" è solo un’altra dimostrazione di come il nostro sistema giudiziario sia più interessato alla forma che alla sostanza. Non importa se la vittima ha paura ogni volta che sente un telefono squillare o se si guarda le spalle per strada. Se non ci sono prove tangibili, come un cambio di residenza o l’abbandono del lavoro, il sistema tende a sottovalutare il problema.
E così, in un’Italia dove ogni problema diventa un cavillo legale, lo stalking non è tanto un reato contro la persona quanto un reato contro la burocrazia: esiste quasi esclusivamente solo se lo puoi dimostrare con un certificato di cambiamento di residenza o una lettera di dimissioni.
Forse, invece di chiederci se la vittima ha cambiato le proprie abitudini, dovremmo iniziare a cambiare le nostre leggi. E, soprattutto, il modo in cui le applichiamo. Perché una società che non protegge le sue vittime, ma le obbliga a dimostrare quanto sono traumatizzate per essere credute, non è una società giusta. È solo un’altra versione del grande circo italiano, dove la giustizia è uno spettacolo e le vittime sono il prezzo del biglietto.