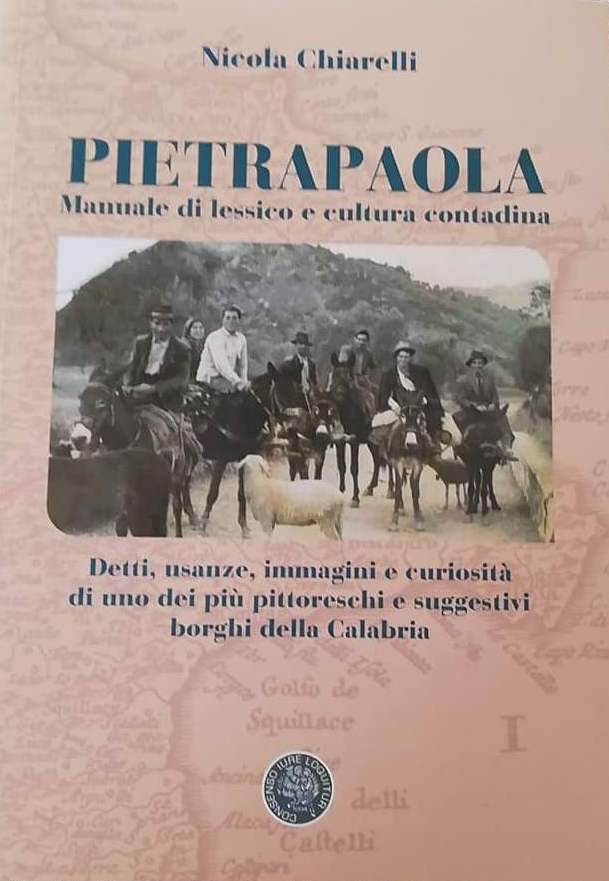Postfazione di Vito Sorrenti
A lettura conclusa, accingendomi a scrivere le mie sintetiche considerazioni su quest’opera monumentale dell’amico Nicola Chiarelli, che rielabora, amplia ed approfondisce i contenuti del volume dato alle stampe nell’agosto del 2014, con il titolo “Dizionario Dialettale di Pietrapaola” (Ferrari editore), mi sono posto la seguente domanda: “Qual è stata la molla che ha spinto l’autore a dedicare 10 anni e più della propria vita per strutturare questo enorme edificio?”. La risposta che mi sono dato è stata la seguente: “U šcàrminu”. Che cos’è “U šcàrminu” ce lo dice l’autore stesso: nostalgia; languore; tormento d’animo, forte desiderio, ansia, voglia, smania, agitazione; stato di ansia o nervosismo.
Questo insieme di sensazioni, assimilabili a quelle che prova l’innamorato “costretto” ad allontanarsi dall’amata, l’autore l’ha provato nel momento dello strappo, della “lacerazione” dei legami affettivi; ossia nel momento in cui si vide “costretto” a lasciare il paese natio per emigrare in Germania, come si evince dalla lettura di una sua poesia tratta dalla silloge poetica “U Castellu”, Grafosud, Rossano 2006, intitolata “Omminu e Petrapavula”: “Mi ne sugnu iuto / ccù quattru nzone ntra na valicicchja / e ccu nu bagullu chjinu e ricordi. / Che scàrminu er a terra mia, / chi m’è rimastu ntru core!”.
U scàrminu, quindi, è uno stato d’animo generato dall’amore, dall’amore che aspira alla ricongiunzione con il mondo che l’ha generato ossia la propria terra e le proprie radici”; dall’amore che si prova per le persone e i luoghi cari e che si intensifica e si fa struggente nel cuore di chi, per validi motivi, è “costretto” a distaccarsene; dall’amore che non vuole che venga del tutto reciso il “cordone ombelicale” che lega ogni essere umano alla sua comunità, alla comunità che lo vide venire alla luce.
E alla luce di ciò, possiamo dire che è stato l’amore a spingere il nostro autore a progettare e ad innalzare con l’ausilio del cuore, il vigore del pensiero e l’eleganza dell’arte, questa eccelsa cattedrale ove aleggia l’anima di Pietrapaola e vi dimora l’identità della sua gente e l’autenticità della sua parlata, della sua cultura e della sua storia.
Una cattedrale costruita con i lemmi usati dalla comunità pietrapaolese fin dai tempi più remoti, che racchiude al suo interno, come reliquie dentro uno scrigno prezioso, memorie di persone, di luoghi, di usanze, di costumi di tradizioni, di modi di dire, nonché proverbi, aneddoti, imprecazioni, curiosità e altro; una cattedrale all’interno della quale il lettore può ritrovare non solo i segni distintivi della gente vissuta all’ombra della rupe in quel periodo che va dall’immediato dopoguerra alla fine del secolo scorso, coincidente, peraltro, con la fine del millennio, ma anche echi e note del suo antico passato.
Un passato che ha visto germogliare e diramare, attraverso i secoli, la genuina e incorrotta cultura contadina, intrisa di valori inestimabili, che ora rischia di scomparire definitivamente; un passato che gli antenati, a partire da quelli che innalzarono la così detta “Muraglia di Annibale”, sono riusciti a tramandare ai posteri e che costituisce un patrimonio che l’autore vuole far conoscere alle generazioni future mediante la sua meritoria testimonianza esplicitata nel presente volume.
Un volume frutto di un serio lavoro e di una meticolosa ricerca capace di soddisfare anche i palati più esigenti tramite la capillare elencazione di tutte le parole dialettali estinte o in via di estinzione, ove il compilatore non si limita a dare la definizione del lemma o la spiegazione del suo significato, ma va oltre, aggiungendo ulteriori informazioni e indicazioni per mettere in rilievo le qualità, le proprietà, le specificità, ecc. della persona, dell’animale o della cosa menzionata. A tutto ciò, in molti casi, con fare ispirato, aggiunge, per completare il discorso, i così detti “modi di dire”, le imprecazioni, le invettive appropriate, i proverbi più consoni, che permettono al lettore di godere di quelle sfumature e coloriture rintracciabili solo nella parlata familiare.
Un lavoro finalizzato a rievocare un passato recente ma che, alla luce dell’evoluzione tecnologica susseguitesi rapidamente negli ultimi decenni, che ha apportato numerosi cambiamenti nella vita di ogni essere vivente e profonde trasformazione nella totalità delle attività umane, appare assai remoto. È sufficiente soffermarsi su alcuni lemmi come: aràdiu, bägnu, cucinäre, lämparìna, lavastuvìgghje, locänna, lùcia, telèfunu, televisiòna, ṭṛappìtu, varrilàra, vucàta, ecc. oppure su quelli relativi agli strumenti e agli attrezzi usati dai contadini per il lavoro nei campi, su quelli usati dagli artigiani nelle loro botteghe e su tutti quelli annoverabili come attrezzi del mestiere per avere contezza di ciò.
Ancora più remoto e sotto molti aspetti fortunatamente distante appare quel tempo che ha visto l’asino e l’uomo convivere insieme sotto lo stesso tetto e le galline razzolare dentro le case e per le vie del paese. In questo contesto il giovane lettore stenterà a credere veri quei “racconti” che descrivono le dimore e i relativi arredi; stenterà a credere che nuclei familiari costituiti da numerosi individui potessero convivere in un tugurio che fungeva da camera da letto e da sala da pranzo, da salotto e da cucina e che al posto del gabinetto vi era il così detto pisciatùru ossia: “un vaso da notte; orinale; recipiente di ferro smaltato, porcellana, terracotta (lievemente più rialzato), con un manico, nel quale si orinava e qualche volta si defecava…”.
Sebbene il nostro autore, autentico innamorato della sua terra e delle sue radici, faccia rivivere la Pietrapaola della sua fanciullezza e della sua prima giovinezza con la dolcezza, la tenerezza e la nostalgia di chi ha perso il suo paradiso ossia il suo mondo incantato e ancora incontaminato, animato da persone laboriose, ospitali, genuine e incorrotte, ricche di valori e di ideali, di fede e di pudore, di amicizie sincere e di atteggiamenti solidali, innumerevoli e assai dolenti e a volte terribili sono le “testimonianze” che si susseguono nelle pagine che informano il volume e che al lettore odierno possono sembrare di volta in volta incredibili e, in pari tempo, drammatiche (vedi, ad esempio, le voci: bacchètta, cäne, rìzzu, ecc.).
Altrettante numerose e di volta in volta gustose, deliziose, vivaci, erudite, ironiche, tenere, strane e divertenti, le “curiosità” di ogni genere e in particolare intorno alle credenze popolari, alle superstizioni, alle stagioni, alle seminagioni, alla luna e alla meteorologia, alle novità tecnologiche, agli animali, alle persone, alle piante e via dicendo. Di seguito a mo’ di esempio riporto alcune voci estrapolate fra le tante, dove ogni lemma racconta una storia infarcita di qualche singolarità o stranezza, stravaganza, ecc.: abbitìnu, acìtu, Bèliche, cacatìna, chjänca, cumpèttu, D.D.T., dàźźiu, emigrazziòna, falignämu, gabbìna, gagumìlla, jòcca, jùssu, ligurìźźa, lùna, lùttu, männa, päne, ògghju, quaṭṛarèlla, Rigänni, špruvèru, šṛamätu, tavùtu, telèfunu, ùgna, virginità, vràscia, vucàta, Zilàta, ecc.
Molti i nomi relativi alle vallate, alle zone agricole, ai fondi, ai poderi che consentono all’autore di dilungarsi sugli aspetti pittoreschi e sulla gioia di vivere a contatto con la natura e, in pari tempo, di esaltare le qualità paesaggistiche degli stessi dipingendo angoli di “Arcadia” di straordinaria bellezza e suggestione come quelli relativi alle voci: Acquarella, Cuccu, Mäju, Rigänni, ecc., brulicanti “di arcaica, operosa e melodiosa vita bucolica”.
Uno spazio notevole occupano anche le voci che si riferiscono alle coltivazioni dei campi e all’allevamento degli animali per i quali l’autore non perde occasione per manifestare la sua tenerezza e la sua simpatia, nonché quelle relative ai cibi, ai condimenti, alle bevande e ad altro (vedi le numerosissime ricette culinarie), che suscitano nel lettore più attempato una nostalgia struggente e un profondo rimpianto per quella cucina frugale ma genuina, per quelle pietanze razionate ma gustose, per quei sapori e quegli odori non più rintracciabili, per quei gusti e quelle prelibatezze ormai difficilmente reperibili o irrimediabilmente perduti.
Ma non sta in ciò il merito prevalente dell’opera. Il merito maggiore, a mio modesto parere, è nel suo aspetto epico e nel suo tratto narrativo costruiti intorno a quelle voci che danno all’autore l’occasione per mettere in mostra la sua cultura, il suo sapere e le sue conoscenze per scrivere dei veri e propri saggi, tramite i quali, oltre ad enunciare il significato del lemma, lo contestualizza e ne descrive le qualità del soggetto o dell’oggetto citato, esprimendo, in pari tempo, le sue considerazioni, più o meno sintetiche. Ciò si rileva con maggiore evidenza soprattutto quando il lemma serve per ricordare il nome (vedi tutti quelli preceduti dal “titolo” “don”) o il soprannome di una persona, nonché le vicende o vicissitudini che l’hanno interessata. Qui l’autore dà la cifra della sua capacità di osservazione, della sua sensibilità e delle sue doti psicologiche e umane. Qui fa rivivere e palpitare stili di vita, atteggiamenti seri o caricaturali, abitudini e attitudini, comportamenti, manie ecc. di persone più o meno note, conosciute direttamente. Qui dipinge l’uomo che si muove nel suo habitat naturale per esercitare la sua attività lavorativa, i suoi doveri sociali, i rapporti con gli altri in un contesto caratterizzato, il più delle volte, dalle quotidiane ristrettezze, dalle annose tribolazioni, dalle forzate rinunce e dagli inevitabili sacrifici.
Sotto questo aspetto, ossia nella rassegna dei numerosi “personaggi”, la stragrande maggioranza dei quali ormai defunti, il volume si presenta come una sorta di Spoon River, con la differenza sostanziale che nell’Antologia di Edgar Lee Masters sono i defunti a raccontare la storia “infelice” della propria vita dalla quale lasciano trapelare, come in una sorta di confessione, aspetti appartenenti alla sfera privata, caratterizzati da intrighi, ipocrisie, peccati e tormenti interiori, mentre nell’”Antologia” del nostro autore, è egli stesso che tratteggia i personaggi mettendo in rilievo, di volta in volta, l’aspetto umano o spirituale, il tratto saliente, la dote o la capacità particolare, il vizio o la virtù, ecc.
Per dare al lettore l’idea della bravura narrativa del nostro autore e della sua capacità di approfondire e arricchire di particolari le vicende umane narrate, nonché della sua onestà intellettuale nella ricostruzione letteraria della vita dei personaggi presenti in questa opera, riporto integralmente il testo relativo alla voce Baràbba: soprannome di un ex arciprete di Pietrapaola di nome Don Giovanni Saracino, (Saracinu) originario di Rossano. L’origine di tale soprannome dovrebbe risalire al fatto che un giovane, negli anni Cinquanta, dopo una cerimonia della Settimana Santa, a cui aveva assistito in chiesa, “affibbiò” all’uscita spontaneamente all’allora non tanto “amato e stimato” arciprete, allorché questi nel corso della precedente predica ricordò ai fedeli riuniti in chiesa, di voler rispettare in occasione del prossimo Venerdì Santo il precetto religioso del digiuno, cosa che però non avrebbe fatto lui, nel senso che avrebbe cammaratu, per il semplice fatto che gli toccava predicare ed accudire alle incombenti cerimonie religiose successive. Il soprannome Barabba, anche se non del tutto attinente, rispecchia anche il fatto che Don Giovanni «…lasciava a desiderare per il suo ministero pastorale…», come conferma il suo successore, Don Ferruccio Locco, nei suoi Ricordi di Pietrapaola, 1949-51 (Tarsia, febbraio 2005), anche se allo stesso tempo sostiene che fu «marcato ingiustamente» di questo titolo ingiurioso. Domenico Tridico, che per un determinato periodo è stato amministratore dei beni dell’Arcipretura, nelle sue memorie dal titolo "Pietrapaola. Un secolo di storia", 1999, cita addirittura che l’arciprete Saracino bisticciava con diversi coloni dell’arcipretura, persino durante le funzioni religiose, definendolo «persona di scarsa cultura, inaffidabile, cavilloso e confusionario». L’autore è comunque del parere che sia più fondato il giudizio di Don Ferruccio Locco, che quello espresso dal Tridico, per altro molto azzardato ed inavveduto. Baràbba negli anni Cinquanta non possedeva una macchina, ma un bel cavallo, sebbene un po’ magro, al quale era molto affezionato e un calesse (carrozzinu). Malgrado il suo predecessore Don Ciccio Scarnati in un locale al pianterreno della canonica vi avesse impiantato un teatrino, Barabba, che amava il suo inseparabile cavallo forse più di quanto avesse fatto Caligola, ve lo teneva alloggiato, quindi lo aveva adibito ad una stalla vera e propria. Il calesse, su cui di notte si appollaiavano spesso le galline del vicinato, imbrattandolo di escrementi, invece lo metteva al riparo in una grotta di via Roma, fra a Gghjazza e lu Riu, dove più dardi si costruì la bottega Mäšṛu Rèliu e Cucurunu. Infatti, fino alla demolizione dall’angusto Arcu er u Culonnellu e al suo ampliamento, avvenuto qualche anno dopo, non poteva arrivare col calesse fino alla Gghjazza e quindi nṭṛu Vagghju, situato fra la canonica e la casa di Salvatore Giudice, a parte del fatto che anche qui a causa di un gàfiu, sul quale durante le feste patronali si facevano i ncänti, il passaggio era troppo stretto. Saracinu usava il suo calesse quando doveva recarsi alla stazione ferroviaria o addirittura al suo paese natio Rossano, dando spesso un passaggio a qualche paesano che era a piedi, per proseguire poi per la Statale 106 Ionica, allora non ancora asfaltata, e sicuramente non ancora “strada della morte”, come è diventata in seguito, per una lunga serie di incidenti stradali con innumerevoli vittime. L’autore ricorda che negli anni Cinquanta in mancanza di altri mezzi di circolazione, viaggiò insieme con suo padre e con sua nonna Rosa sul carrozzinu guidato da Don Giovanni Saracino personalmente, il quale li accompagnò da Pietrapaola alla stazione ferroviaria, dove suo padre prese il treno per accompagnare la nonna all’ospedale di Corigliano”.
Insomma, in questa grande opera, corredata dall’illuminante prefazione del prof. Luciano Crescente e dal raffinato e colto saggio introduttivo del prof. Michele De Luca, che somma circa 650 pagine nelle quali sono elencati in ordine alfabetico, oltre 11.000 lemmi dialettali e utilizzate circa 400.000 parole in lingua italiana, latina e in dialèttu petripalisi per spiegare il loro significato e, in pari tempo, dare forma al volume complessivo, il lettore può attingere ogni tipo di informazione sul “Borgo rupestre che s’affaccia sul mare del mito e della storia; sul mare che diede i natali all’amata Afrodite, la dea dell’amore, sul mare che fu solcato dagli eroi del pensiero e dagli alfieri dell’avventura e, in pari tempo, dai padri della cultura e della civiltà occidentale”. A tal proposito giova ricordare che Pietrapaola si trova a metà strada tra Sibari e Crotone, due delle più potenti e gloriose città della Magna Grecia.
Concludo dicendo in tutta onestà di aver appreso molte cose e soddisfatto molte curiosità, leggendo questo libro che, come ha scritto il prof. Luciano Crescente nella sua già citata prefazione, è una vera miniera di ricerca storico-antropologica attraverso - il taglio della “storia orale” -; e di conseguenza, dico io, una miniera di notizie di ogni genere che costituiscono un patrimonio immateriale prezioso e ricco di fascino da conservare e condividere. Un patrimonio storico-culturale ove chiunque sia nato “nel paese aggrappato alla sua rupe / come un bambino al collo della madre” o abbia radici pietrapaolesi, può attingere per soddisfare ogni sorta di curiosità e, cosa ancora più importante, ripercorrere, guidato dall’autore, i sentieri e le vie battute dai propri antenati. Un patrimonio messo insieme dall’autore giorno dopo giorno, con dedizione, passione e fatica, per surrogare e far rivivere il suo paradiso perduto e, al contempo, alleviare lo scàrminu generato dalla “lacerazione dello strappo”. Un patrimonio che arricchisce e dà lustro all’intera comunità la quale deve sentire nei confronti dell’autore e della sua meritoria e nobile impresa, sincera stima ed eterna gratitudine.