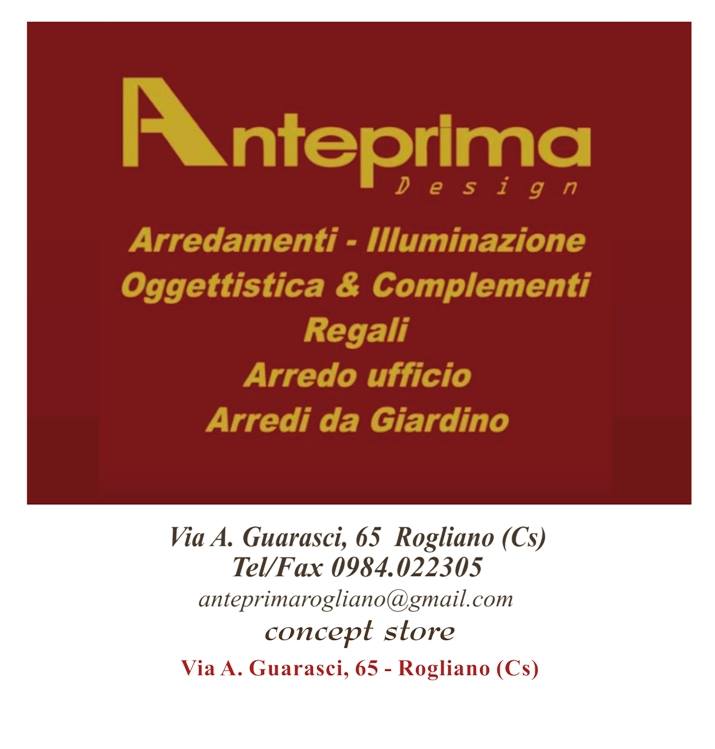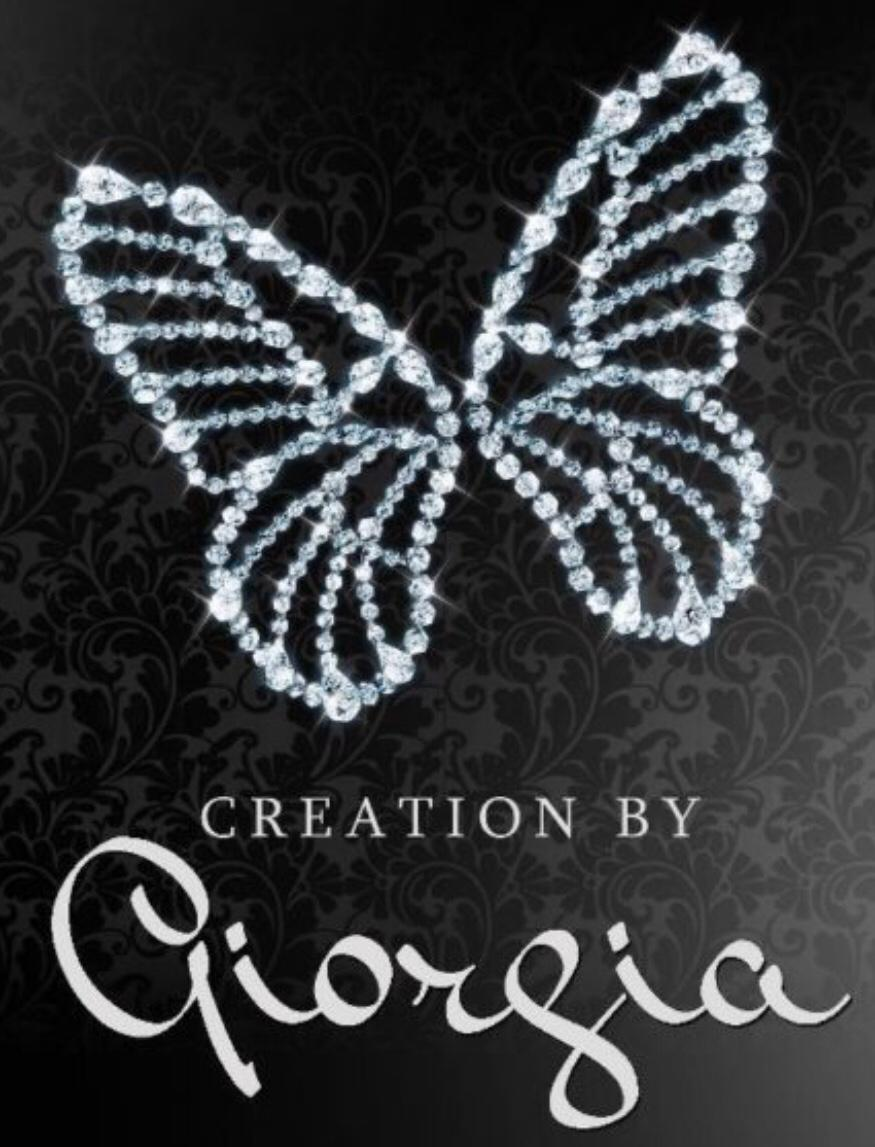di Monica Vendrame
C’è una strana ossessione, ultimamente, nel voler mettere le mani sulle storie che hanno accompagnato generazioni di bambini. Si riscrivono finali, si cambiano personaggi, si stravolgono simboli secolari in nome di un’idea di modernità che somiglia più a una forma di miopia culturale. Come scriveva G.K. Chesterton, «Le fiabe non insegnano che i draghi esistono, ma che si possono sconfiggere». Eppure, oggi sembriamo più preoccupati di cancellare i draghi che di insegnare a combatterli.
Prendiamo il caso dell'ultimo remake di Biancaneve: un film che, nel tentativo di essere "inclusivo", ha prodotto un autentico fiasco. I sette nani sono stati sostituiti da creature digitali senz'anima, il principe trasformato in un ladro redistributore di ricchezze, e persino il nome della protagonista ("pelle bianca come la neve") ridotto a metafora di una tempesta meteorologica. Il risultato? Un flop clamoroso. Le polemiche non hanno risparmiato nulla: gli attori con nanismo esclusi da ruoli storicamente loro, la protagonista Rachel Zegler (attrice ispano-americana) ha dovuto giustificare il nome Biancaneve con una spiegazione grottesca: nel remake, non deriva dal suo aspetto leggendario, ma dall'essere sopravvissuta da bambina a una bufera di neve. Non si tratta più di adattamento, ma di snaturamento. Come se qualcuno avesse deciso che "Giuseppe Verdi" dovesse scrivere musica elettronica per essere più attuale.
Le favole parlano per metafore, non per tweet. La scarpetta di Cenerentola, il bacio che risveglia Biancaneve, lo specchio magico della regina cattiva: sono simboli che parlano direttamente all’inconscio. Quando si tenta di "aggiornarle", ciò che si ottiene non è una versione più giusta, ma solo più povera. Privare le fiabe dei loro contrasti – il bene e il male, la bellezza e la bruttezza – significa togliere loro l’anima.
C’è una certa ironia nel voler "proteggere" i bambini dalle fiabe tradizionali, quando la vita reale è ben più crudele di qualsiasi racconto dei fratelli Grimm. Eliminare il lupo da Cappuccetto Rosso non prepara i più piccoli ad affrontare i pericoli; al massimo, li lascia più indifesi. Le fiabe classiche sono state per secoli una palestra emotiva: insegnavano che le difficoltà esistono, ma che possono essere superate.
Riscrivere o rispettare?
Il vero progresso non sta nel censurare il passato, ma nel comprenderlo. Invece di stravolgere le favole, varrebbe la pena insegnare a leggerle nella loro complessità. Se si vuole innovare, si creino nuove storie. Ma le fiabe tradizionali dovrebbero restare intatte, come monumenti della nostra cultura.
Modificare le fiabe classiche per adattarle alla sensibilità moderna è come applicare uno strato di glitter su un diamante: non lo rende più bello, solo più kitsch. La forza di queste storie risiede nella loro autenticità, nel coraggio di mostrare il bene e il male senza filtri.
Forse, invece di riscrivere le fiabe, dovremmo reimparare ad ascoltarle. Perché in quel «C’era una volta» non c’è solo fantasia: c’è una saggezza antica che sa ancora parlare al cuore, se abbiamo il coraggio di lasciarla intatta. E se temiamo così tanto la loro magia, forse è proprio perché ci ricordano ciò che abbiamo dimenticato: che la vita può essere crudele, ma anche meravigliosa, e che siamo capaci di affrontarla. Questo è il dono più prezioso che le fiabe ci offrono – a patto di non svuotarle per riempirle di luccichio.