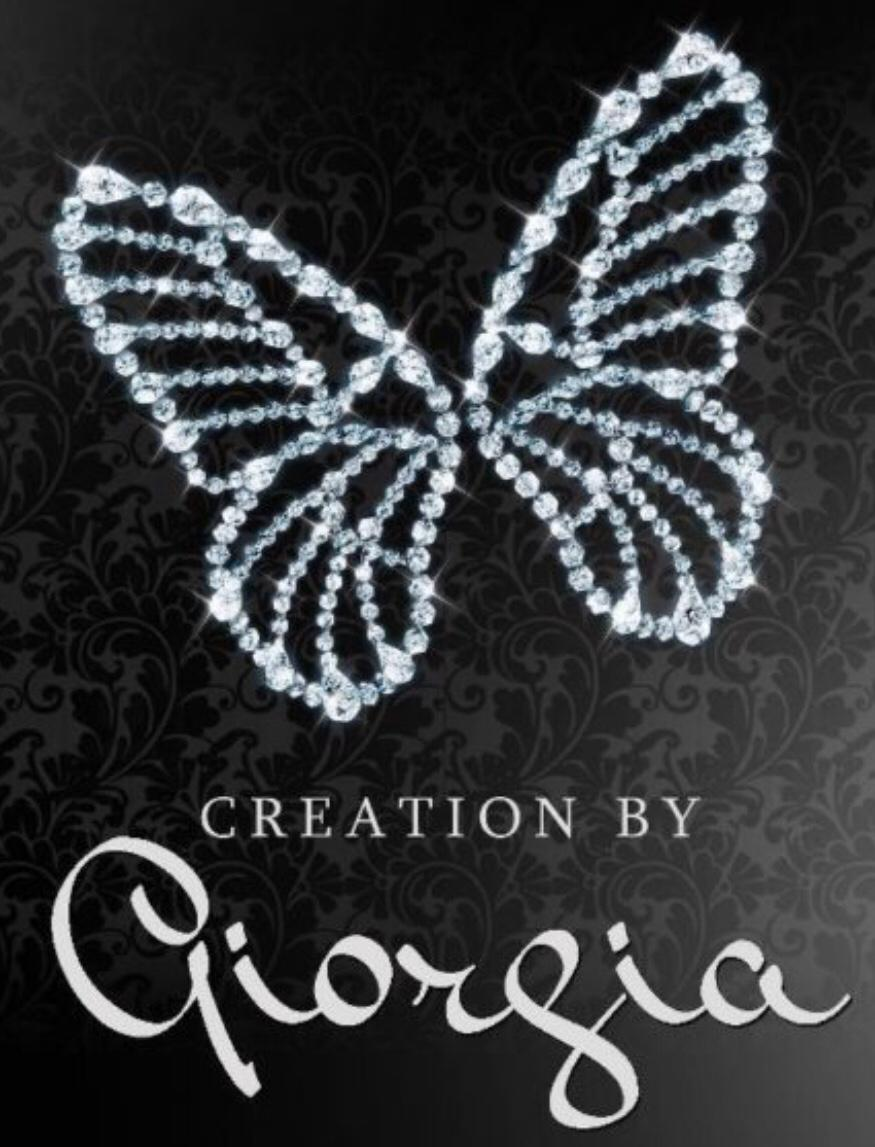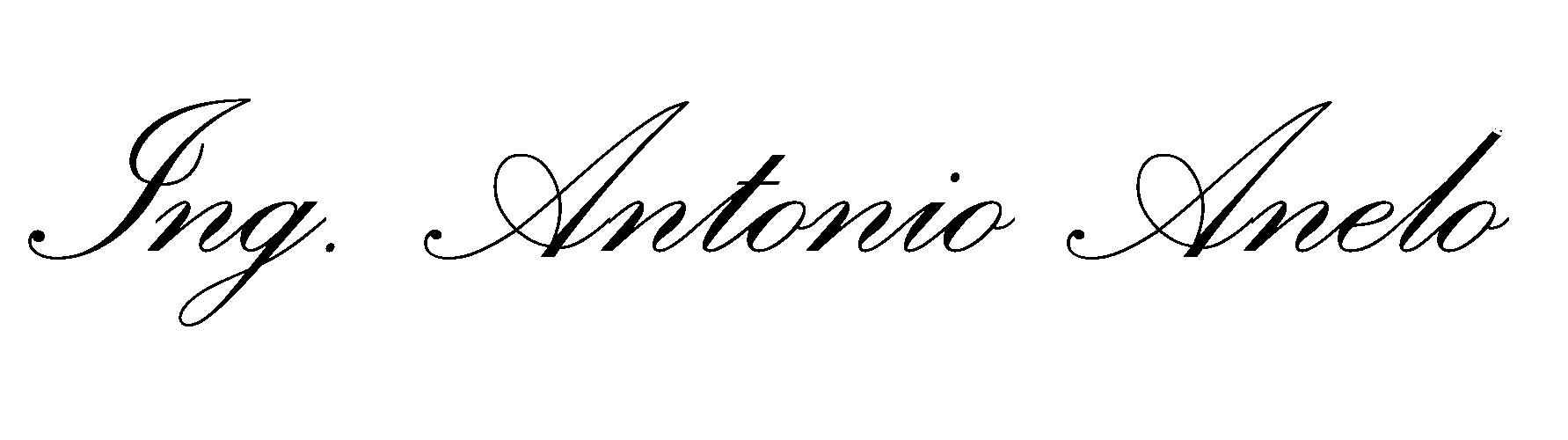Intervista di Silvia Giampà
Ciao Nadia, benvenuta e grazie per aver accettato di essere intervistata sul giornale “La Voce agli italiani”. Raccontaci chi sei…
Credo di essere nata sapendo che avrei avuto un destino particolare. È quella strana consapevolezza che non ha fondamenti scientifici ma che arriva molto prima dei fatti, molto prima di quegli avvenimenti che hanno fatto di me una bambina e un’adolescente “diversa” e molto prima di quell’incidente stradale che mi ha costretto in una carrozzina all’età di 21 anni.

Oggi fai parte della Comunità Papa Giovanni XXIII…
Sì, oggi faccio parte di una grande famiglia, la Comunità Papa Giovanni XXIII, in cui mi ritrovo fortemente come carisma, identità e appartenenza. Fondata da un grande prete, Don Oreste Benzi, che ci ha lasciato nel 2007 ma il cui ricordo ed esempio è ancora vivissimo in noi. La Comunità ha come particolare carisma la condivisione della vita con coloro che nessuno vuole, con coloro che vivono ai margini della società, con gli “ultimi”. Da sempre “anima in pena”, in cerca di esperienze e motivazioni forti per dare un senso profondo a questa mia esistenza, a questo vivere adesso-qui-oggi, della Comunità Papa Giovanni XXIII mi è sempre piaciuta la concretezza, l’agire, l’andare anche contro tutti in favore di chi non è difeso da nessuno, il non poter dormire in pace sapendo che qualcuno ha bisogno, che fuori della tua calda casa c’è qualcuno che soffre: credo, spero, siamo questi oggi i segni particolari della mia carta di identità.
Quali sono le esperienze più particolari che ricordi?
Tra le esperienze più particolari annovero sei mesi di condivisione con gli zingari in un campo nomadi, decine e decine di notti trascorse in strada tra le ragazze schiavizzate e costrette a prostituirsi.
Da quando hai ammirato questa Comunità?
Ho ammirato da fuori questa Comunità quando, agli inizi degli anni Novanta, andava tra le popolazioni in guerra nella ex Yugoslavia: non riuscivo a capire perché delle persone “normali” andavano tra le popolazioni in guerra, per stare con loro. E andavano sia in un fronte che nell’altro. Non capivo questa “follia” ma ne ero affascinata.

Ricordi il tuo primo contatto diretto con la Comunità?
Il mio primo contatto diretto con la Comunità fu una sera alla “Capanna di Betlemme”: una casa dove la notte trovano riparo e cibo caldo tutti i barboni e i senza tetto della stazione di Rimini e non solo.
Oggi sono passati un po’ di anni, sono responsabile di una delle tante realtà di accoglienza della Comunità Papa Giovanni XXIII, dove la quotidianità spesso assorbe ogni energia, ma è facile capire che, nell’ottica del nostro carisma che ci spinge a rimuovere le cause che creano ingiustizia, a condividere, non solo fare assistenza, non ho mai disdegnato inviti “forti”.
Poi hai iniziato ad entrare nelle carceri e hai incontrato gli ergastolani ostativi. Dicci qualcosa…
Più volte negli anni, anche se in maniera sporadica, sono entrata nelle carceri in cui altri membri di comunità portavano avanti progetti di incontro e colloquio con i detenuti. Fino al giugno 2007, quando venne Don Oreste al carcere di Spoleto. Ricordo benissimo quel giorno perché ha segnato la mia vita. Non avevo mai incontrato ergastolani, conoscevo l’alta sicurezza, persone condannate a pene molto, molto, lunghe, ma non sapevo che cosa fosse un fine pena mai. Non avevo mai visto il volto di uomini che volevamo far morire in carcere, persone murate vive. Quel giorno erano lì, davanti a noi, a raccontarci questa storia assurda dell’ergastolo ostativo, persone vere, che sembravano più dei collegiali tristi che delinquenti pericolosi. Persone che raccontavano storie umanissime, drammi immensi e che non chiedevano sconti, né si proclamavano innocenti. Volevano solo una speranza e qualcuno che portasse fuori la loro voce. Dicevano che erano sepolti vivi, con la benedizione della Legge e della cosiddetta giustizia, ma volevano almeno che qualcuno lì fuori lo sapesse a che cosa li avevamo condannati. Don Oreste, da sempre un po’ più avanti degli altri grazie a quella “luce” della mente che è propria dei santi anche quando sono ancora in vita, disse subito di sì, disse che li avremmo aiutati, che saremmo stati al loro fianco. Solo qualche mese dopo Don Oreste morì, ma nel suo ultimo discorso pubblico, alle Settimane Sociali di Pisa nell’ottobre 2007, parlò degli ergastolani di Spoleto, parlò di loro fino alla fine, dello sciopero della fame che avrebbero iniziato di lì a poco. Sì, perché pochi sanno che centinaia e centinaia di ergastolani, per anni, hanno fatto lo sciopero della fame nel mese di dicembre, per richiamare l’attenzione sulla loro situazione. E sono stati sempre puntualmente ignorati dai media. Eppure stavano rischiando tutto quello che avevano: la loro vita in cambio di una speranza di vita. Quanto avrei voluto ignorarli anch’io. Ci ho provato. Fino a quel dicembre 2007: ero una settimana all’estero in una delle rarissime vacanze con la mia famiglia, ma non trovavo pace, tutti i giorni pensavo a loro e, mentre mi abbuffavo di cibi succulenti, pensavo a questi uomini che non mangiavano da settimane per far sentire la loro voce. Nessuno ne parlava. Così tutti i giorni cercavo un internet point per andare a leggere un sito che pubblicava il diario dal carcere di Carmelo Musumeci, con la speranza di trovare la notizia che avevano smesso, così almeno potevo godermi la mia vacanza. Ma non fu così, non mi godei quella vacanza e, tornata a casa, non smisi più di seguirli: in cuor mio, avevo già deciso che sarei diventata “voce di chi non ha voce”.
Nei mesi seguenti il contatto con loro divenne sempre più forte fino a richiedere di essere autorizzata ad entrare in carcere in modo continuativo.

Cosa hai provato?
Posso dire che non avrei mai immaginato di conoscere tanta umanità, tante persone splendide e, senza retorica, posso dire che questa esperienza mi ha cambiato la vita. Ma parlare di esperienza è riduttivo, perché la storia, la vita di questi uomini, mi hanno preso in maniera tale da non trovare pace finché qualcosa non cambierà anche per loro.
Finché una persona non parla con loro, e con i detenuti in generale, ha l'idea del cattivo, del mostro, del delinquente, quasi dell'alieno che non ci riguarda. In realtà, quello che io ho sempre trovato sconvolgente entrando in carcere, è stato scoprire che dietro quelle mura e quelle sbarre ci sono delle persone assolutamente normali, come noi.
Io non escludo che se avessi avuto una storia diversa, una vita diversa e delle possibilità diverse, non potrei essere stata al posto loro. Io sono nata nel miracoloso Nord-Est, ho avuto una famiglia normale e sono cresciuta bene, ma se fossi nata in Sicilia? Forse non sarei la brava volontaria che va aiutare gli ergastolani. Probabilmente avrei un padre, un fratello, uno zio in galera e sarei la parente di un detenuto. Il carcere non è un mondo a parte, non è vero che lì ci stanno soltanto gli orchi, i mostri.
Cosa ti spinge a continuare ad essere la “voce degli ergastolani”?
Mi spinge innanzitutto l’eredità lasciataci da Don Oreste nel suo pensiero espresso con lo slogan “L’uomo non è il suo errore”: ogni volta che mi trovo davanti ad uno di loro riesco solo a vedere un uomo, con la sua totale dignità.
A volte vorrei scappare da tanto dolore, ma poi rimango qui e continuerò ad essere la loro testimonianza fuori, per quelli che non sanno, perché non c’è nulla di più facile che aver paura di ciò che non si conosce, e io continuerò ad essere la loro voce.

Tu hai un cuore grande e riesci a vedere il bene in ogni persona…
I carcerati vanno amati, non sono gli errori che hanno commesso. Gli ergastolani sono persone come noi. Credo solo che loro, come tutti, abbiano diritto a una speranza.
Noi partiamo dal presupposto che l'uomo non sia il suo errore. Una persona resta una persona, con una sua dignità, che mantiene in quanto portatore di un valore umano unico. Se al male si aggiunge altro male lo si moltiplica. Un assassino non si può redimere con la punizione. Chi ha commesso dei reati va fermato per evitare che ne compia altri e per cercare di fargli capire dove ha sbagliato, ma credo che chi ha fatto del male vada prima di tutto amato. Credo sia necessario concentrarsi sul bene che manca e che c'è dentro ogni persona, anche quella che ha compiuto i gesti più efferati.
Quando un detenuto si rende conto che non è soltanto l'errore che ha commesso ma che porta dentro anche qualcosa di buono e che addirittura può diventare una risorsa per gli altri, allora è portato a fare una revisione critica delle sue gesta. Questo non accade con l'isolamento, con le punizioni, le torture, le botte. Don Oreste diceva: "Quando uno ha compreso il male che ha fatto, ogni giorno di galera in più è un giorno sprecato per il bene dell'umanità", perché l'essere umano è sempre una risorsa. Per tutta la società.
Cosa pensi del carcere?
Il carcere, nelle modalità in cui oggi viene fatta scontare la pena, non rieduca. Chi termina la sua pena dietro le sbarre nell'80% dei casi torna a delinquere. Alcuni mi hanno detto: "Sono entrato che ero un povero Cristo, esco che sono un delinquente incallito". Punire per il solo gusto di punire non giova alla sicurezza della società, perché riporta fuori delle persone che si sono incattivite, che si ritrovano imbruttite e che quindi, una volta uscite, tornano ad essere dei criminali.
Nelle nostre strutture, quando accogliamo persone in misura alternativa al carcere, capita molto spesso che decidano di rimanere nonostante abbiano finito di scontare la loro pena, perché sono stati a fianco di bambini in difficoltà o giovani con problemi di tutti i tipi. In quelle occasioni hanno potuto dare. Quando si riscoprono risorsa per gli altri allora scatta in loro il desiderio di cambiare vita. Infatti, per chi finisce la pena fuori (per esempio nelle nostre strutture), la recidiva non supera il 15% che è lontana dalla statistica nazionale (80%). La comunità lancia il messaggio "meno carcere, più sicurezza", che sembrerebbe paradossale ma invece è questione di logica: tanto carcere non ossigena la sicurezza della collettività. Che utilità ha una pena per cui un uomo passa 20 ore al giorno in una cella a non fare niente?

C’è stata qualche occasione in cui hai avuto paura?
Il carcere cambia e plasma l'uomo, quindi chi incontri dentro non è mai quello che hai visto e sentito raccontare dai telegiornali. Mi è capitato di passare tante ore in mezzo a loro: talvolta le guardie carcerarie, che avrebbero dovuto riaprirmi, si dimenticavano della mia presenza e capitava che io stessi anche più del tempo dovuto con i detenuti, che non sono proprio degli ex boyscout. Non mi sono mai sentita in pericolo e non ho mai avuto paura.
Ringrazio Nadia per questa intervista.