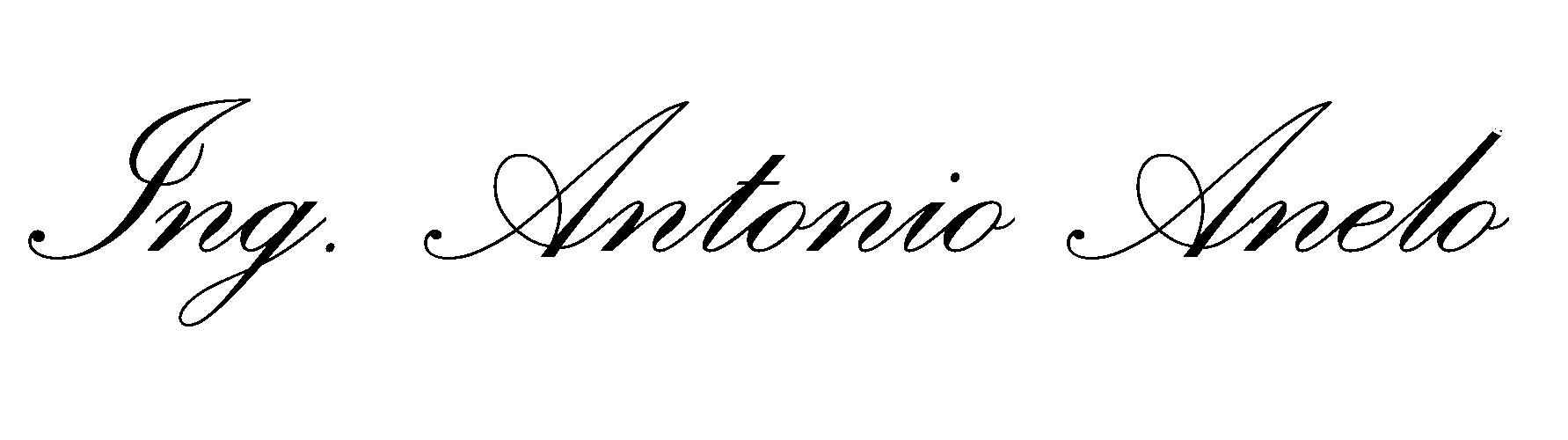di Stefano Dentice
Roberto Silli è un chitarrista jazz e compositore dall'animo gentile. Il suo stile, sottrattivo e mai autoreferenziale, è caratterizzato da cantabilità, lirismo e senso melodico. Tre elementi indispensabili che, nella sua visione della musica, sono come ossigeno e acqua. Raccontare e descrivere immagini, pensieri che si traducono in note, è il suo mantra. The Forgotten Mirror, il nuovo capitolo discografico pubblicato dall'etichetta Wow Records, registrato insieme a due talenti come Federico Gili alla fisarmonica e Stefano Nunzi al contrabbasso, rappresenta una sorta di autoritratto del jazzista romano. Lui, con sette sue composizioni originali e un amorevole tributo all'immenso pianista Bill Evans, dipinge una fascinosa tela sonora, dal mood impressionista, intrisa di sostanza espressiva.
Partendo dagli albori, hai intrapreso il percorso musicale approcciando al rock per poi dedicarti al jazz. Quando e come, interiormente, hai avvertito l’esigenza di esplorare il mondo jazzistico?
«Da adolescente suonavo come autodidatta la musica che era intorno a me. Il rock e il blues esercitano un grande fascino, un impatto emotivo immediato, soprattutto a quell’età. Poi, in Italia, non è facile entrare in contatto con il mondo del jazz. Accadde un giorno, forse verso i diciassette o diciotto anni, che un amico mi prestò alcuni dischi in vinile di Bill Evans: non sapevo chi fosse, né di quale genere musicale si trattasse, ma appena ascoltato compresi che quella musica meravigliosa fondeva in sé tutto ciò che ritenevo più prezioso. Perciò decisi che avrei studiato proprio il jazz. Quello fu l’inizio e, subito dopo, mi portò a scoprire anche Chet Baker, Jim Hall, John Coltrane, Wes Montgomery e via via tanti altri grandi maestri. Conobbi la bellezza di questo genere e dell’improvvisazione come racconto in musica, ma soprattutto iniziai a desiderare di esprimere me stesso in quel modo. Bill Evans, tuttavia, è sempre stato l’inizio di tutto e ha ancora un posto speciale dentro di me».
Nell’arco della tua carriera hai incontrato numerosi jazzisti di statura nazionale e internazionale con i quali hai condiviso il palco. C’è un mentore che credi sia stato di vitale importanza per la tua crescita artistica?
«Credo che, inconsapevolmente, vivere delle esperienze musicali di valore porti a mutare in profondità il modo in cui pensiamo e percepiamo la realtà. Quindi, in tal senso, anche ascoltare per vari anni Bach o Chopin, come successe a me da bambino quando scoprii i dischi di mio padre, può essere una via per creare interiormente, e in maniera inconsapevole, una sorta di mentore, di guida. Se però intendiamo un rapporto reale, umano, posso certamente dire che ho avuto la fortuna di incontrare in Fabio Zeppetella, grande chitarrista jazz, una figura fondamentale per la mia crescita. Fabio, con il quale poi è nato un rapporto di profonda amicizia, attraverso la sua concezione musicale e la poetica del suo suono, mi ha fatto intravedere dove volessi veramente andare. Insieme a lui, però, non posso non riconoscere l’importanza di un altro fantastico musicista, il chitarrista Enrico Bracco, da tanti anni ormai per me come un fratello. Con lui ho condiviso tanta musica e momenti di vita. Quindi, essendo molto simili per sensibilità, abbiamo anche sviluppato un’intesa musicale fuori dal comune».
The Forgotten Mirror è la tua nuova creatura discografica realizzata insieme a Federico Gili alla fisarmonica e Stefano Nunzi al contrabbasso. Cosa racconta questo “specchio dimenticato”?
«In realtà il titolo è arrivato all’ultimo, quando ho iniziato a realizzare cosa avevo composto. Essendo un album tendenzialmente introspettivo, la figura dello specchio tende in senso metaforico a suggerire la possibilità di vedere, nel suo riflesso, la verità della propria fisionomia interiore, spesso sconosciuta o dimenticata. In questa ricerca, la presenza di musicisti come Federico Gili e Stefano Nunzi è stata essenziale. Per sensibilità, poesia, talento e capacità di fondersi con me, sono stati eccezionali».
Soffermandosi sulla composizione della formazione, balza subito all’occhio e all’orecchio la mancanza della batteria. Come mai la scelta di non completare il trio con un batterista?
«L’intento era di cercare un suono d’insieme che avesse un proprio fascino, che potesse evocare qualcosa dal profondo. Non sarebbe bastato comporre i brani senza un trio in grado di creare una particolare miscela cromatica, una suggestione di suoni e silenzi. In tutto ciò, probabilmente, la presenza della batteria avrebbe aggiunto qualcosa di superfluo, mentre per questo progetto la mia idea è sempre stata quella di agire per sottrazione, mirando all’essenziale come guida e strumento di indagine interiore».
Nell’album figurano otto brani, di cui sette sono frutto della tua ispirata vena compositiva, mentre l’unico standard è Turn Out the Stars di Bill Evans. Pur essendo chitarrista, cosa ti ha spinto a rendere omaggio a un colosso del piano jazz come Evans, da te già menzionato, piuttosto che, per esempio, a una leggenda della chitarra jazz quale Jim Hall?

«Come già espresso in precedenza, Bill Evans rimane probabilmente la mia influenza più profonda. Io, pur non essendo un pianista, considero la sua musica talmente tanto dentro la mia coscienza musicale da ispirarmi in molti modi diversi. Tutto, per me, è iniziato con l’ascolto di questo leggendario jazzista, dunque devo a lui quel momento in cui la bellezza si è dischiusa davanti ai miei occhi e mi ha condotto nella mia direzione. Nelle note di Evans, nel suo modo di suonare, ho sempre avvertito tutte quelle qualità che mi spingono a fare della musica il mio mezzo espressivo».
Il tuo stile, soprattutto dal punto di vista compositivo, è intensamente comunicativo, profondo, irenico. Dal vivo, nei concerti di presentazione di The Forgotten Mirror, in cuor tuo, ti aspetti che il pubblico percepisca questo tratto distintivo connaturato nel tuo DNA artistico?
«Secondo me la musica è tante cose, ma innanzitutto un mezzo meraviglioso, un patrimonio di bellezza che l’essere umano crea e condivide per arricchire il suo bagaglio esistenziale. Comporre e suonare, nel mio caso, rappresentano la necessità di esprimere gli aspetti più veri, più profondi di me stesso, nel tentativo di rendere partecipi gli altri di un’esperienza di sincerità e umanità, così come è sempre accaduto a me».